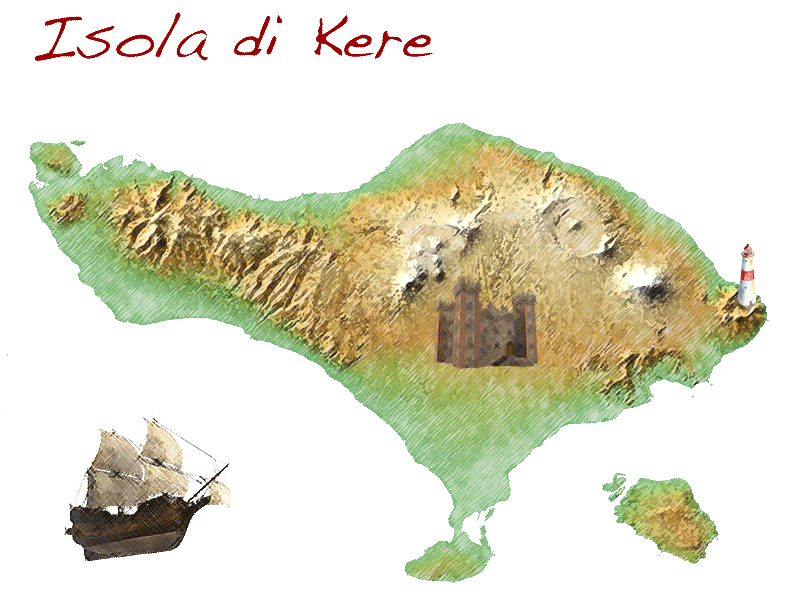

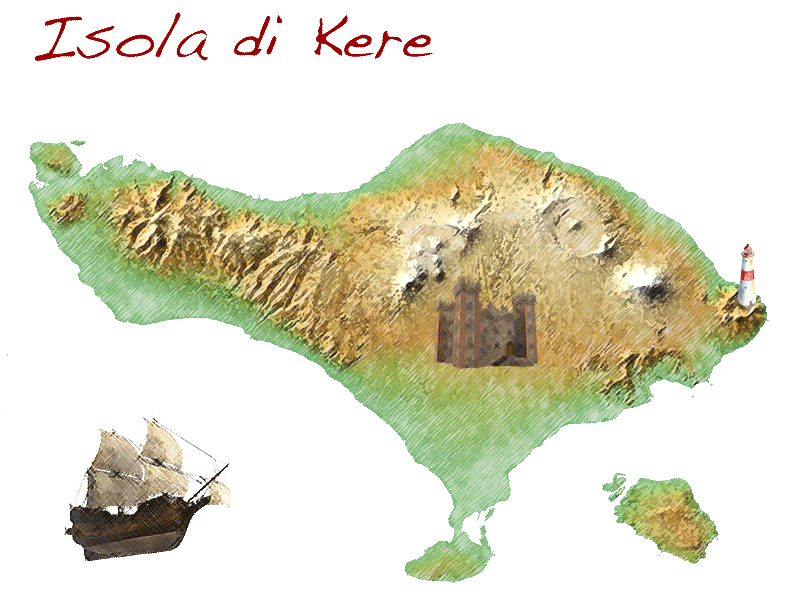


Nella Baia della vera finzione arrivano i mercanti di storie; scrittori, poeti, saggisti, contrabbandieri e bugiardi per vizio o per mestiere.
12-01-2024
12-01-2024

Tengo sempre gli occhi bassi
Fissi sulla strada sporca
Devo
Non mi è permesso ammirare il Mondo
Non gli appartengo
Non esisto.
Le mani sempre davanti al mio viso, più in alto della fronte con i palmi rivolti verso l’alto Oggi peró il profumo è più buono degli altri giorni
Sta passando accanto a me
Oggi li alzo gli occhi
Che bella bambina!
Piccola ma già principessa
Ti sta bene il tuo vestitino, sei meravigliosa sorellina mia!
Mi hai sorriso e toccato le dita con la tua manina candida
È la più bella elemosina che potessi ricevere oggi
Si vai!
Non guardarmi!
La tua mamma ha ragione!
Perdonami!
Tengo gli occhi bassi
01-12-2023
Il testo di Ruggero Bellettini nasce in un laboratorio di scrittura per studenti dell’ultimo anno di liceo, tenuto da me a Spezia. È una proposta all’interno del premio Chatwin, un concorso internazionale che ha premiato i più bravi scrittori di viaggio, ma anche i fotografi e i disegnatori.
Luciano Damiana, direttrice artistica e anima del premio ha sempre avuto in mente anche studenti e studentesse e mi ha chiesto un’idea: mi è piaciuto immaginare un reportage a chilometro zero, ovvero un racconto di viaggio fatto a piedi nella propria città, seguendo degli itinerari assolutamente arbitrari dati da me.
Quello di Ruggero è scritto molto bene, magari tra venti anni vincerà il premio Chatwin.
Leggi l'articolo di Ruggero Bellettini "Resoconto di viaggio" (PDF)
17-07-2023

E ci risiamo: la mania di scrivere il proprio nome, addirittura di inciderlo magari con una chiave o un temperino sul Colosseo: che ci sia una bella dose di ignoranza è ovvio, i genitori della ragazzina svizzera hanno reagito stupiti: “Ma che c’è di male”. Si arriva forse a capire che non si può aggiungere un disegnino a pennarello alla Gioconda, magari un fumetto che dice quello che pensa – e questo sarebbe già un atto creativo, seppure per niente originale – ma un muro? Via, che c’è di male se ci scriviamo i nostri nomi intrecciati per l’eternità.
A Roma andai, a noi pensai, questo ricordo eterno vi lasciai.
Il fatto però merita qualche pensiero in più e lo appaio a un’altra abitudine non nociva: quella dei selfie di fronte al campo di girasoli di Van Gogh o ad altra opera celeberrima di Jan Vermeer, magari la Ragazza con l’orecchino di perla, rilanciata nella pop cultura da un romanzo e da un film, e poi finita sulle tovagliette per la colazione, le magliette. Non è un dettaglio, non lo si farà mai di fronte a un quadro bellissimo ma a noi ignoto. Come se si condividesse un briciolo di importanza, se quel “Io c’ero” ampliasse la percezione del “Io sono”: si danno le spalle all’opera e noi davanti, tappandola alla vista ma non troppo, perché altrimenti chi capirà che eravamo al Louvre? Il tempo di osservazione dell’opera è di pochi secondi, altre orde armate di bastoncini telescopici per il selfie premono.
Il senso dell’identità appoggiato a un’immagine di sé che dura una manciata di secondi, quelli che precedono il passaggio nel cimitero delle foto del nostro smartphone. Quindi un io transitorio, precario, da rinnovare continuamente. Lo stesso uso di Facebook spesso va in questa direzione: ero lì, facevo questo, e il mondolo deve sapere. E’ vero che la nostra identità si costruisce sullo sguardo dell’altro, della mamma e del papà, ma poi si autonomizza, siamo capaci di essere diversi, indipendenti. Una certezza che poggi anzitutto sul senso di sé.
La sostituzione della parola immagine alla parola onore dice molto di più di quanto sembra, pur attingendo sempre all’opinione dell’altro su di noi: e la cosa buffa e che l’altro di noi se ne infischia nella maggior parte dei casi, come noi dell’altro.
Rimedi? Piccole sacche di educazione familiare e scolastica, imparare e insegnare a prendersi il tempo per guardare, sentire, odorare con calma la vita.
06-03-2023
Redi scrittura
Riscaldamento. Firma attuale, bambina, adulta, vecchia
Aubi in sette minuti, aubi falsa in 15
Lucchese, molto di più di quanto vorrei: dal 1851, non io, ovvio, ma quell’appartamento in via Fillungo parlava di borghesia benestante, eppure quando ci ho abitato io faceva freddo, non c’era il riscaldamento , il bagno era uno. Finito il benestare. 8 anni di cui ricordo poco, meglio la casa in periferia, calcio tutti i pomeriggi, le ragazze alle medie ma ero un anno avanti e non mi si filavano: quelle avevano le prime tette e io ero alto un metro e mezzo. Al liceo la musica è cambiata, via la religione, pallosissimo liceo classico, una pena di 5 anni, nessuna ispirazione, la scherma continua ma non ho i risultati che speravo dopo le finali toscane. Vincere sessanta anni dopo, basta resistere. Un matrimonio , due convivenze, finalmente la famiglia. Loana, Mariangela, Patrizia e finalmente Francesca venticinque anni insieme, Tommaso e Martina, i due ori , primi ex aequo nell’amore, un senso vero del vivere. Sempre meno attaccamento, mentre mi avvicino ai tornelli della notte
Bio fantastica
Non ho più un corpo, non è una brutta sensazione, ma mi ci devo abituare. Sono solo nella sala d’attesa, nessuno mi dice nulla. C’è una donna, sicuro che mi sta osservando, la posso sentire. eccato non vederla
Tu aspetti da molto ?
Sei nuovo, vero ? Qui il tempo va calcolato in eoni
- In che ?
In eoni. Piùo meno come trentamila anni sulla terra. Io sono qui da un eone.
Ti ci abituerai.
Ma come funziona ? il giudizio universale ? la bilancia degli egiziani con la piuma ?
Ma noo, Ti fanno vedere un campionario e scegli i genitori , il luogo di nascita
Quindi dico se dico Bali figlio di un principe ?
Troppo comodo. La scelta dipende da quello che devi imparare
E io che ne so ?
Si mette male, meglio che ti faccia un’idea sennò ti danno la nascita d’ufficio, e può essere molto deprimente. Genitori di scarto, periferie industriali. Chiaro che c’è sempre da imparare.
Lo dice guardandosi attorno, guardinga.Teme di essere ascoltata
Ti confesso, io vorrei essere brutta
O perché
Ero bellissima, mai nessuno che mi considerasse per il cervello e non per il culo. Ho anche fatto la reclame degli slip Roberta.
Una voce chiama
Bocconi Andrea ! in stazione
-Che strano, ti rimandano subito giù. La devi aver fatta grossa. In pratica respinto. Io solo due crediti formativi: sessualità e ignavia.
Incrociai le dita e mi avviai.
Si ricomincia col parto, l’ultima volta manca poco che ci resto secco e torno subito in base uno.
Ma come mi chiamo ? Ah già, non conta più il nome vecchio. Annamaria ? Oddio.
06-03-2023
08-11-2021

Sorseggio il mio tè. Mi diverte sentirmi straniera: al bar Striccoli di Altamura nessuno beve il tè.
Al tavolo di fianco al mio ci sono due ragazze adolescenti, alle prese con le prime sigarette. Le aspirano lentamente, con un certo orgoglio. “Non ci credo che ti ha detto così”, dice la più grande, passandosi una mano tra i riccioli mori.
“Lo giuro Robbè.”
L’altra insiste: “5000 euro so’ un sacco di soldi. Ma i suoi non sono contadini?”
“Sì, ma ci tengono.”
“Che vuol dire, pure i miei ci tengono, ma mica spendono tutto per il mio diciottesimo.”
“Pare che Ninetta fa pure il video del pre-diciottesimo.”
“Pre-diciottesimo?” ripeto a bassa voce mentre penso che agli adolescenti di oggi la situazione sia davvero sfuggita di mano.
Robbè scuote la testa con aria abbattuta, poi, come se niente fosse, si scatta un selfie mentre succhia la granita. “Senti,” prosegue con voce preoccupata: “ma quanti invitati fa Ninetta?”
“83. Però a scuola dicono che saranno 85, se vengono pure le sue cugine di Bari. Tu quanti ne hai?”
“Eh, io 70.”
“Ah. Ce l’hai almeno il dj?”
“Lo fa mio fratello”, risponde Roberta con un po’ di imbarazzo.
“Non va bene, Robbè, devi arrivare almeno a 80.”
“E chi invito?”
Le ragazze iniziano a guardarsi intorno; mi sento osservata.
“Ho un’idea!” dice la più giovane. “Vieni, ti aiuto io!” Non penseranno mica che…
“Signora!” Trasalisco. È il cameriere. “Che lo volete un pasticciotto? Qui li sappiamo fare bene eh.”
Nemmeno il tempo di rispondere che le due ragazze sono sparite, a reclutare nuovi invitati.
Il loro tavolino viene presto occupato da una coppia di anziani, vestiti di tutto punto.
Lui sorseggia un caffè, con sguardo triste. Lei scuote la testa, con aria severa.
“Che peccato! Che uomo in gamba!”
“Non esageriamo, che Mario era uno sciupa femmine”, esclama la moglie.
“Appunto”, risponde il marito e aggiunge: “proprio un uomo di successo”.
“Ma se aveva rovinato il negozio di famiglia transformandolo in un gastro… gastro…”
“Un g-a-s-t-r-o-b-a-r!” dice il marito scandendo le lettere con precisione.
“Ecco, quella cosa lì. Ma come gli era venuto in mente?”
“Rosa, ma hai presente quanti soldi si era fatto in questo modo? A 50 anni già non aveva più bisogno di lavorare.”
“Certo, e così perdeva tempo in chiacchiere e a correre dietro alle femmine non accompagnate. Anzi, pure a quelle maritate o peggio: a quelle divorziate con i figli”.
“Se ti riferisci a Lucia, guarda che quella sì che è una signora…”
“Ma che dici, se non sa nemmeno stendere i panni! Tutti disordinati li mette. Mica si fa così, bisogna essere capaci.”
“Dai, Rosa, che con quello che le è successo…”
“Le posso portare qualcos’altro?” Ci metto qualche secondo a capire che il cameriere sta parlando con me.
“No grazie, va bene così”, dico a bassa voce, mentre cerco di seguire la storia dei due signori. Eravamo a Lucia, che le sarà successo?
“Nemmeno una tetta della monaca? Le facciamo noi, sono fresche fresche…”
“Ma no!” Rispondo seccata. Un paio di clienti si girano a guardarmi. Il cameriere rimane di sasso. “Mi scusi, sì, me le porti pure!” Aggiungo subito, con un certo imbarazzo.
Il mio sguardo torna al tavolo dei vecchietti. Troppo tardi, stanno già percorrendo corso Federico II, mano nella mano.
“Stai calma”, dice una voce maschile.
Mi volto di colpo e vedo un uomo sui 45, con una lieve stempiatura sul lato sinistro della testa. Sta parlando al cellulare. Si sente una voce femminile provenire dall’apparecchio, dal tono isterico.
“Marina, amore mio, stai calma”, ripete l’uomo con voce rassicurante.
(Voce isterica di Marina al telefono).
L’uomo continua a bere il suo latte di mandorla con tranquillità e prosegue: “che problema c’è, ai matrimoni si guarda l’abito degli sposi, mica quello delle invitate.”
(Voce isterica al telefono).
“Scusa, ma mo’ perché dovrebbe essere colpa mia?”
(Voce isterica al telefono).
“Che c’entra? Ti ho solo detto che con il vestito blu stavi bene, che ne sapevo io che se lo metteva pure la figlia di zia Rosanna.”
(Voce isterica al telefono).
“Non si può andare a cambiare lei, che abita dietro la chiesa?”
(Voce isterica al telefono).
“Ah, lei è la parente più prossima… Eh va bene, allora torna a casa tu e cambiati.”
(Pianto al telefono).
“Mah sì che hai tempo, stai tranquilla”
(Voce suadente al telefono).
“In che senso ne devi comprare un altro?”
(Voce suadente al telefono).
“Ma quanto costa?”
“Sono 10 euro!”. Mi dice il cameriere che si è avvicinato al mio tavolo.
“Cosa?!?” Rispondiamo all’unisono io e l’uomo al telefono.
Eh, signorina vi siete mangiata 3 pasticciotti, 2 tette di monaca, poi c’è il tè caldo…
Sì, sì va bene, taglio corto io. Posso pagare con la carta?
Il cameriere mi fa un sorrisino. “Oggi non funziona…”
Mi alzo e vado alla cassa a pagare. Sento riecheggiare per la piazza: “Marina, ma sei pazza!”
Sorrido e mi incammino verso il mio bed & breakfast. Lungo la strada vedo Robbè e la sua amica, intente a reclutare nuovi invitati tra i ragazzini del paese. “Arriveranno a 90” penso tra me e me e già me li immagino tutti vestiti per la festa.
27-07-2021
Mi chiamo Cristina. A venti anni ho lasciato il tetto familiare per andare a vivere in autonomia.
Le cose che ho fatto:
Cameriera in ristorante, babysitter, pulizie in studi medici, aiuto scenografa in diversi teatri d'Italia, centralinista e accoglienza persone in struttura societaria, gestione in società di un bar, impiegata in ufficio per varie aziende private e per un'associazione di categoria, interprete di lingua inglese e francese, hostess per aziende presso fiere in Italia e in Francia, aiuto cuoca in albergo, impiegata in un caf per dichiarazione dei redditi, agente di polizia municipale, impiegata amministrativa in uffici comunali nel settore dei servizi sociali, nell'ufficio gestione del personale, nell'ufficio sviluppo economico e turismo, segreteria assessorati comunali.
Mi sono dedicata anche ad attività sociali e istituzionali: in gruppi politici giovanili, in associazione di volontariato a livello locale, regionale e nazionale, consigliera circoscrizionale, assessore comunale, sindacalista.
Nel frattempo ho regalato al mondo mia figlia.
Scarica il raccondo "Storia di una formica che voleva scalare una montagna" di Cristina Banci (formato PDF)
31-10-2020

Teatro Petrarca di Arezzo, Domenica : ultimo spettacolo del Festival dello spettatore l, ci sono tutti gli organizzatori. Si chiude in bellezza, Ballarini di Emma Dante, un testo danzato e interpretato potente, divertente, commovente, fa parte della trilogia degli occhiali, sul tema della vecchia: danza e dialetto siciliano. Bello
Ma c’è sgomento , c’è tristezza :da domani si chiude di nuovo, perché ? I protocolli sono rigidi, uno spettatore ogni tre sedie, mascherine, gel. Sanificazione.
È per gli orari ? Per il coprifuoco ?
Ma gli spettacoli si possono fare anche sabato e domenica pomeriggio.
E’ per il numero degli spettatori ? Meno di un terzo della capienza, meno degli avventori di un ristorante.
E’ perché la cultura è un lusso ? No, è un genere di prima necessità, c’è bisogno di bellezza, di idee , di distrazione, in questo momento più che mai. La musica ha salvato l’anima di gente nel campo di concentramento.
Tutti i lavori vanno salvaguardati, ma lo sapete che gli attori di teatro, salvo rare eccezioni, hanno paghe modeste e solo quando lavorano ? E le maestranze, i tecnici, i registi, i montatori ? Tanta gente che già galleggiava nei tempi buoni, e ora rischia di andare a fondo.
Non facciamo distinzioni strane, non facciamo guerre tra poveri,
Teatri, cinema, sale di concerto: non soffocatele, lasciate un po’ d’aria, quelle che tiene in vita. Con regole rigidissime.
La cultura è un genere di prima necessità. : attenzione , l’essenziale è invisibile per gli occhi, diceva il Piccolo principe.
25-04-2020

Testo di Andrea Bocconi, foto di Fabrizio Magnani
Il Canal du Midi è un capolavoro dell’ingegneria civile francese del Seicento. Corre per duecentoquaranta chilometri tra Tolosa e il Mediterraneo, è largo una ventina di metri, profondo due. In origine serviva a trasportare il grano senza passare per lo Stretto di Gibilterra, ma negli ultimi decenni è utilizzato per svago: canottaggio, pesca o ciclismo. Inoltre si può risalirlo con una houseboat, una specie di gigantesco camper d’acqua dolce.
Proprio questa era stata la mia proposta e, contro ogni aspettativa, le due famiglie, perfino i figli, l’avevano accettata subito, nominandomi capitano all’unanimità (con la mia prudente astensione). Mia moglie Francesca aveva individuato quella giusta per noi: otto posti letto, due bagni, salotto e cucina. Quattordici metri galleggianti. Dal momento che non si affronta il mare aperto, non è richiesta nessuna patente nautica; chiunque può guidare – pardon, portare – la barca. Ottimo dal momento che le mie precedenti esperienze si limitavano a qualche breve uscita in mare, ospite in una barca d’altri, di mio al massimo avevo remato con uno di quei pattini che ti affittano a ore in Versilia.
Tutto facile, a parole. Ma quando mi arriva il manuale del capitano mi sorge subito qualche perplessità: sono davvero parecchie le cose da sapere (e da saper fare). Prima c’è tutto un vocabolario marinaresco da imparare: poppa e prua, pompe di sentina, cime (e non funi) da cazzare e lascare, bitte, ormeggi (guai a chiamarli parcheggi!). Ma non si scappa: se si vuol fare i marinai, bisogna curare anche lo stile. C’erano poi alcuni disegnini poco rassicuranti, per esempio il mezzomarinaio (non è un nano) per allontanare la barca dalle pareti delle chiuse; va impugnato nella maniera giusta, altrimenti puoi cascare nel canale o sfondarti qualche costola. C’erano poi anche le istruzioni legali in caso di incidenti: altro che constatazione amichevole, non bisogna ammettere nulla.
Una visita pomeridiana all’amico Leonardo, espertissimo di barche e di houseboat, aveva solo peggiorato la situazione. Le istruzioni erano aumentate a dismisura, e si erano protratte fino a cena e anche dopo. Potevo chiamarlo anche in viaggio, se avessi avuto qualche problema, qualche dubbio. Più mi rassicurava e più mi sentivo inquieto. Il suo “Fammi sapere come va” mi aveva ricordato le richieste della mamma: “Telefona quando sei atterrato”. Non si sa mai.
Il viaggio verso il porto di partenza è stato un incubo: ai francesi piace interrompere il flusso del traffico con frequenti caselli: Bouchon (tappo) dicevano i cartelli rossi dell’autostrada: lo abbiamo imparato subito. Siamo arrivati al porticciolo di Argens Minervoise appena in tempo per ritirare la barca.
Quando feci un cammino con gli asini, il corso da asinaio durò una mattina intera, e non fu sufficiente. Qui un giovanotto stanco ci ha fatto la lezione di scuola guida in venti minuti, teoria e pratica. D’altronde quel giorno ne aveva già consegnate ventuno e non vedeva l’ora di andare a casa. Mi ha messo al timone e una breve uscita di dieci minuti è stata sufficiente per sbattere due volte contro i muri dello stretto passaggio. Ci doveva essere abituato, perché non ha fatto una piega. Io aspettavo che si arrivasse a parlare delle terribili chiuse, ben centotre, necessarie per superare centonovanta metri di dislivello lungo il percorso. Come le avrei superate? Il mio istruttore è pragmatico e sintetico: sono troppe cose da sapere, non ve le ricordereste, guardate come fanno gli altri.
Partiamo al mattino, in una bella giornata di sole. Immaginate che per andare in città invece della vostra macchina vi diano un autobus di quattordici metri: le strade vi sembreranno strette. E poi il timone non è un volante. La barca comincia le curve in ritardo e con ritardo si raddrizza. Vira di poppa, con una deriva da calcolare; ha i suoi tempi. C’è un’elica di prua che aiuta le manovre, ma l’istruttore se l’è dimenticata. La scopriremo dopo due giorni e innumerevoli collisioni con le mura delle chiuse; i parabordi con noi lavorano. La seconda chiusa si conferma chiusa per noi: sbattiamo forte. Poi in qualche modo passiamo e ormeggiamo in un grazioso porto, Oms. Per fortuna che c’è un ristorante col buon vino delle regione. Nessuno ci farà l’alcol test.
La mia prima notte da capitano d’acqua dolce è tormentata. Francesca mi fa una psicoterapia antiansia di emergenza e siccome è brava al mattino ripiglio il comando; d’altronde nessuno desidera sostituirmi e provare l’ebrezza della guida. L’alzaia è stata trasformata in una pista ciclabile, invidio i ciclisti che pedaleranno per tutta la lunghezza del canale. Poi, protetto dalla buonanima di qualche antenato marinaio, miglioro; avanziamo tranquilli tra i magnifici filari di platani, vediamo campagne e piccoli borghi. Impariamo a entrare nelle chiuse insieme ad altre due houseboat: è come parcheggiare tre camion in un fazzoletto. L’equipaggio funziona a meraviglia. Tommaso e Fabrizio saltano a riva, Alma e Martina legano le cime con nodi perfetti, Amina provvede alla cambusa, Francesca oltre alla terapia di supporto al pilota fa di tutto. La paura ritorna quando in una curva del canale incrociamo una chiatta di trenta metri, ma ormai sappiamo manovrare.
Scivolare sull’acqua a cinque nodi permette di essere rilassati e concentrati allo stesso tempo. La bellezza tutto intorno è un nutrimento, la mente entra in uno stato meditativo a occhi aperti, siamo tutti tranquilli e anche più buoni. Quando ormeggiamo a Carcassonne registriamo sensazioni contrastanti. Da un lato ci fa piacere scendere a terra, passeggiare lungo la duplice cerchia di mura, persino andare al cinema; eppure ci sentiamo un po’ straniti, specie quando la permanenza si prolunga per un guasto alla pompa di sentina (proprio quella che avevo studiato male). Nell’ultimo porticciolo dove lasciamo la barca faccio uno spettacolare ormeggio a marcia indietro tra due barche. Peccato che sia finito ora che avevo imparato. Ma progettiamo già altre navigazioni; pare che quella nella laguna veneta sia magnifica.
23-04-2020
Di seguito potete vedere i 10 vincitori del concorso "Sia breve, per favore" lanciato lunedì 16 Marzo 2020 online con un video.
24-02-2020
Perché si compra un romanzo? Il consiglio di un’amica, una recensione intelligente, il parere del libraio competente (raro, sia il consiglio che la competenza, ma ci sono).
Io “Niente caffè per Spinoza” l’ho comprato per il titolo e per una nota biografica sull’autrice, Alice Cappagli: violoncellista della Scala dal 1982. Il fatto che sottolineasse di essere livornese mi interessava meno, ma leggendo il romanzo ha il suo bel peso.
Una storia delicata , una donna trova un lavoretto da un professore di filosofia cieco, che le chiede spesso di leggere qualche brano: Epitteto, Pascal. La filosofia come consigli per la vita, appigli di memoria per lui, pensieri che le si insinuano e la spingono a cambiare la sua vita. Un incontro che fa bene a tutti e due, il professore è meno solo, lei si affeziona a lui e al pensiero di questi maestri. Livorno è molto presente, non uno sfondo ma un luogo dell’anima. Non mi ha entusiasmato l’uso del dialetto per qualche personaggio, ma è peccato veniale. Spinoza, il grande Spinoza, leggetelo ne La questione Spinoza di Yalom. Qua non gli si offre il caffè. La filosofia serve? Forse sì, del resto è appena uscito in una proposta di Repubblica “Platone è meglio del Prozac”.
22-02-2019
 Secondo appuntamento della Trilogia del viaggio (la relazione del primo è pure disponibile online), evento organizzato da Rete Due e Scuola Club Migros Ticino, nella cui sede luganese si è svolto ieri l’incontro. Davanti ad una nutrita platea, seduti su un divanetto rosso, Sandra Sain, produttrice della nostra radio e il suo ospite, Andrea Bocconi, scrittore di viaggio ma non solo (ricordiamo almeno il libro, con Claudio Visentin, In viaggio con l’asino), psicoterapeuta, molto orgoglioso di essere anche uno schermitore.
Secondo appuntamento della Trilogia del viaggio (la relazione del primo è pure disponibile online), evento organizzato da Rete Due e Scuola Club Migros Ticino, nella cui sede luganese si è svolto ieri l’incontro. Davanti ad una nutrita platea, seduti su un divanetto rosso, Sandra Sain, produttrice della nostra radio e il suo ospite, Andrea Bocconi, scrittore di viaggio ma non solo (ricordiamo almeno il libro, con Claudio Visentin, In viaggio con l’asino), psicoterapeuta, molto orgoglioso di essere anche uno schermitore.
La conversazione, intitolata Viaggio e cambiamento – Perdersi, ritrovarsi, crescere, stimolata dalle domande di Sain, ha avuto in realtà come centro il racconto delle esperienze di Bocconi, seminate da qualche gustoso aneddoto.
Come si diventa viaggiatori? Con genitori e 700 chilometri in auto, lunghi e faticosi, che, partendo dalla nativa Lucca, lo portano a scoprire un’altra costa, costiera, quella amalfitana… e con un padre marinaio dalla valigia sempre pronta… E il primo viaggio, l’epifania, quello che non si scorda mai? Naturalmente, il primo senza la famiglia, lui di diciassette anni e gli amici diciottenni, in auto, in Europa, proprio l’anno dell’invasione della Cecoslovacchia, ma loro hanno deciso di scegliere la Jugoslavia… I viaggi fondamentali, formativi, sono quelli però che non si ricordano, ha sottolineato Bocconi, la nascita, le prime esplorazioni del bambino che va gattonando, che va avanti ma si volta anche indietro per assicurarsi che ci sia la mamma, riproducendo la dinamica del viaggio, misto di istinto di conoscenza e di stabilità e sicurezza.
E oggi, che il mondo è diventato così piccolo, con le nuove tecniche, i droni che ci fanno vedere tutto, che senso ha viaggiare? Ci sono ancora posti da scoprire, anche vicino a casa, basta scegliere percorsi alternativi, spostarsi, sia che si tratti della casalinga Lucca o dell’esotica Bali, occorre superare la pigrizia mentale di andare dove vanno tutti… È il concetto espresso.
E anche la brava Sain è arrivata alla domanda delle domande: turista o viaggiatore? Il primo guardato con una certa sufficienza, persino disprezzo, dal secondo… La differenza che riguarda non la meta ma il modo di viaggiare? Per il “nostro” evidentemente non è una questione di snobistica cultura: quello che torna da una meta lontana e afferma «ci siamo fatti l’Iran» è un turista, mentre la sua parrucchiera che con mente magari ingenua ma occhi freschi racconta la “sua” Parigi, quella è una viaggiatrice. E poi andando più in profondità, la vera questione è il rapporto con il tempo: non visitare in 48 ore Lugano ma dedicarle anche 4 o 5 giorni, per esplorare zone inedite, diverse, periferiche. Per lui il polso di un luogo lo si prende nella bottega di un barbiere o sedendosi su una panchina, ad esempio. Viaggiare è anche scegliere e allora ecco il rimpianto di non essersi fermato in Ladakh, di non aver accolto l’offerta di ospitalità in una fattoria, perdendo un’occasione straordinaria… A proposito di tempo, si parla anche della montagna, dove si misurano le distanze a piedi, in maniera organica, con tutti i sensi aperti, allerta, un modo per mettere il tempo in armonia con lo spazio…
Cosa cerca nel viaggio? Altro interrogativo fatale… Innanzitutto un divertimento, poi mettere alla prova i sensi, mettersi in relazione con un bisogno o una dipendenza… Esserci pienamente (cosa che non avviene in un ambiente divenuto troppo famigliare, abitudinario…), sviluppare dunque la curiosità di capire, d’incontrare persone diverse. Una recente statistica dimostra che il 20 per cento di ciò che ricordiamo sono esperienze di viaggio, perché appunto siamo più presenti (aggiungiamo noi: anche Thomas Mann, a proposito della Montagna incantata, affermava che, contrariamente a quanto si crede, il tempo della noia, ripetitivo, quello della routine, è un tempo breve, perché privo di spessore, di eventi da ricordare…). Il piacere dell’avventura dunque, dell’incontro inaspettato, come in India, quando alla stazione degli autobus, Bocconi è stato importunato da un folle che straparlava e voleva abbracciarlo ma che poi, saputo dove voleva andare, lo ha guidato all’autobus giusto…
Gli scopi del viaggio possono mutare nel corso della vita: oggi, egli afferma, «m’interessa viaggiare per fare, non per vedere», cioè per collaborare a progetti educativi, come Los Quinchos in Nicaragua, lavorando con i bambini del luogo, quelli che vivevano in strada, frugando tra l’immondizia per sopravvivere, ma grazie a questo progetto creato da una professoressa sarda, Zelinda Roccia, oggi abitano in una fattoria, vanno a scuola, imparano un mestiere.
Il viaggiatore è dunque un umanista? Per Bocconi, in effetti, contano le persone, in un confronto con le proprie diffidenze, come quando nella metropolitana di New York, superando le paranoie, ha chiesto informazioni a degli adolescenti neri… Viaggiando, non solo si sconfiggono i pregiudizi, ma anche quelli degli altri nei nostri confronti, qui si è inserito un buffo episodio alle isole Fiji, dove la popolazione del luogo lo ha praticamente costretto ad andare in chiesa (sull’altare l’animale tabù, un polpo in plastica) e persino a tenere un discorso, come ospite straniero!
E a proposito della Scuola del Viaggio, creata dall’amico Claudio Visentin, Sain chiede: Si può imparare a viaggiare? Come qualsiasi tecnica, come disegnare, si può insegnare a viaggiare e a raccontare, perché scrivere è anche terapeutico. E poi ancora, quando si viaggia in coppia, è una prova di resistenza del rapporto, il viaggio. E gli stanziali? Hanno molte frecce al loro arco, è certo che viaggiando non si risolvono i problemi, ci si porta dietro le proprie angosce, è comunque un lavoro duro, si cambia identità, non si è più gli stessi. Infine, può essere un ritrovarsi, viaggiare è raccontare, ascoltare, guardare e anche leggere. L’importante, sembra di aver capito, è che qualsiasi cosa si faccia, la si compia con una buona dose di consapevolezza.
Aspettiamo la primavera per il prossimo e ultimo appuntamento di questa Trilogia: il 21 marzo, sul tema Io viaggio da sola – Storie di donne, protagonista Alessandra Beltrame, in dialogo con Barbara Sangiovanni, responsabile della formazione della Scuola Club Migros, nel cui atrio si terrà l’incontro, alle ore 18.
Manuela Camponovo
(tratto da www.osservatore.ch)
RAI Radio 3 - Pantheon, sabato 23 febbraio 2019
#8 - Bruce Chatwin: l'Alternativa Nomade - Intervista ad Andrea Bocconi (MP3 57,5 MB)
Rete DUE, (Radio Svizzera Italiana), Laser, martedì 7 maggio 2019
Viaggio e cambiamento (link)
21-05-2018

Il video è virale: frati con le loro tonache bianche che stanno in quello spazio vuoto tra la polizia in tenuta antisommossa e i manifestanti disarmati. Si pongono come scudi umani per evitare altro sangue, altri morti.
Somos estudiantes, no somos criminales scrivono i giovani sui cartelli, per contrastare le bugie governative a cui non crede nessuno, per affermare la loro dignità. E’ paradossale che coloro che si chiamano sandinististi, si trovino ora dalla parte della repressione del popolo.
Video di Jorge Hurtado
Daniel Ortega era il capo dei Sandinisti che rovesciarono il dittatore Somoza, ultimo di una dinastia che ha tiranneggiato per 200 anni il Paese. Sandinisti nel nome di Sandino, che aveva sconfitto gli americani che hanno sempre considerato questi Paesi il cortile di casa, sostenendo prima i Somoza e armando i Contras che dall’Honduras lottavano per sostenere gli interessi americani nel paese, uno dei più poveri del centro e Sud America.
Purtroppo il potere esercitato troppo a lungo corrompe, e la coppia Ortega non era più popolare da tempo, in particolare la moglie. L’idea di aumentare i contributi per le pensioni e dare poi meno ai pensionati per rimpinguare le casse depredate del governo è la prova della distanza dal popolo del governo, ed è stata la scintilla che ha incendiato il pagliaio. Non è bastato ritirare la sciagurata riforma, studenti, contadini, il popolo tutto si è messo in marcia, incontrando una repressione che ha lasciato moltissimi morti sul terreno.
27-10-2015

Ho conosciuto Julio quando è arrivato a Lucca da Lisbona, con Cristiana , moglie lucchese e Lorenzo, il figlio in arrivo. Abitavamo vicini, ci vedevamo spesso. Il fatto che giovanissimo fosse stato uno degli studenti di creative writing dell’Jowa University, con insegnanti quali Solinka, TomSoppard e altri di questo calibro mi colpì molto. Era come se mi dicesse che aveva abitato in paradiso.
Quando poi abbiamo saputo che lui stesso, scrittore, teneva corsi negli USA e in Portogallo, ci è venuta subito voglia di organizzare un corso a Lucca. Le sue lezioni erano un godimento intellettuale, si spaziava tra diverse letterature, si scoprivano autori poco noti in Italia a quel tempo, mi basta citare Clarice Lispector, un’emozione. Sarà un caso, ma da quei corsi sono usciti vari autori che hanno pubblicato : Tiziano Fratus, Flavia Piccinni, Francesca Caminoli, Fabrizio Mercantini, Milva Cappellini e anche io.
Stimolati da questa avventura intellettuale, seguimmo Julio in un’altra, nel 1997 : la creazione di Oltrelemura, una settimana dedicata tutta alla scrittura , a Lucca. La sua idea, con la collaborazione di tanti amici, volontari della cultura, portò a Lucca centosessanta allievi, per seguire tra gli altri i corsi di poesia di Valerio Magrelli, di sceneggiatura con Vincenzo Cerami, di Ilide Carmignani per la traduzione , di Stefano Velotti per la lettura e naturalmente di Julio. Un successo straordinario, che purtroppo per l’ignavia degli amministratori locali, con l’eccezione dell’assessore alla cultura Roberta Martinelli, è morta per la mancanza di aiuti minimi. Sembrava di elemosinare per l’utilizzo di una casermetta, neanche una lira di contributo per un’iniziativa che portava in città duecento persone per una settimana, il famoso turismo colto tanto ricercato. Dopo tre anni di volontariato, quando ci abbiamo anche rimesso di persona dei soldi , abbiamo chiuso OLTRELEMURA. Julio aveva ragione, la provincia è provinciale, e anche piuttosto miope.
Julio non era un tipo da arrendersi, la sua storia personale in Brasile lo dimostrava : organizzò il convegno sulla letteratura dei migranti, un tema allora poco toccato, che apriva un dibattito assolutamente attuale che va ben oltre le questioni letterarie.
E poi ha fatto Sagarana, una rivista letteraria bellissima e seguitissima, che spero qualcuno continui, o stampi, o lasci on line, ma che resti.
Come scrittore è stato pubblicato anche in Italia, con molti libri, in particolare da Besa. Purtroppo le case editrici piccole scontano difficoltà enormi di distribuzione e non si possono permettere uffici stampa davvero efficienti. Ciononostante ha raggiunto un suo pubblico.
Come tutti quelli che hanno carattere, sotto la bonomia brasiliana, Julio poteva avere anche durezze : abbiamo fatto almeno tre litigate bellissime, come si conviene tra amici. Passava del tempo e non sentivamo neanche il bisogno di riappacificarsi, continuava l’amicizia.
La lezione più grande , venti anni dopo quelle di scrittura, me l’ha data negli ultimi giorni : una compostezza, una dignità, perfino il suo fantastico umorismo. Non è comune ridere al letto di un moribondo, lui ed io. Presente a se stesso e distaccato, capace di lasciare andare, come un meditante di lunga data, come un monaco buddista, come un uomo libero. Ho capito che questa qualità impeccabile degli ultimi giorni l’aveva conquistata grazie a quello che lui chiamava “ il sacerdozio della letteratura.”
Andrea Bocconi
12-01-2015
Quando, sul finire dell’anno, mi fu proposto di andare in montagna, sulle prime ero veramente indeciso. Poi ad un tratto, mi era balenata in testa la parola Ent.
Pur sapendo che non si trattasse di veri Ent, l’associazione successiva fu quella degli uomini vestiti di erba, della comunità Ladina. Il terzo e finale step, fu collegare tra loro quelle chiamate, e unendole scoprii il carnevale Ladino. Si celebra proprio in Trentino dove mi dovevo recare, e si nutre di questi personaggi. Uomini alti vestiti di muschio, si erano improvvisamente affacciati nella mia testa, misti a ricordi e sensazioni di magie malvagie, benevole e silvestri, di un racconto di Buzzati. Ma sono sicuro che ci fosse anche dell’altro. La chiamata era fin troppo evidente perché io vi rinunciassi.
Decido di unirmi al gruppo e di partire. E di non raccogliere altre informazioni, lasciando al caso il resto. Questo è il resoconto.

Un viaggio riposante e un arrivo al mattino, senza particolari eccitazioni.
Mentre il gruppo che accompagnavo si precipita sui campi da sci, scelgo di andare in alto fin dove la luce del giorno mi potesse consentire di fotografare e ritornare in tempo per la cena.
Scorgo sulla sinistra della strada che mi porta al passo, un fiume adagiato in una forra scura e gelida. Un imperativo fermarsi. Accostata la macchina con due ruote nella neve e due sull’asfalto, scendo a fotografare il ghiaccio con la parola ENT in testa.
Poi al Lago di Carezza coperto di ghiaccio anch’esso. Decido che quello potrebbe essere il posto dove fare le foto notturne, luna piena volendo. Torno a valle che ormai è buio con la sensazione di aver afferrato poco.
Ci dormo su, e la mattina dopo, mentre il gruppo va a sciare, zaino in spalla chiedo al tipo della reception dell’ Hotel, se sa indicarmi qualcuno che produce maschere di legno.
Mi dice che devo andare al museo delle tradizioni Ladine. Lassù, in alto al paese, spiegandomi la strada su una cartina. Camminata di 2 km.
Il museo è recente. Molto bello. Cerco di attaccare discorso con il bigliettaio che non mi considera. Tutti i reperti esposti, i vestiti, le maschere, gli attrezzi, i mobili, emanano una magia particolare almeno per me che cerco i miei link interiori.
All’ultimo piano nascosto dietro una parete di cartongesso, trovo a sorpresa il Salvan … l’ Ent.
Interamente ricoperto di muschio secco, naso e viso pronunciati, che nel ricordo somiglia ad una composizione dell’ Arcimboldo, mi pare, mi fa capire, che non sono arrivato fin li per caso.

L’ostacolo evidente a quel punto, diviene trovare qualcuno che produce le maschere. Scendo di nuovo all’ingresso per uscire, e i bigliettai sono diventati due. Uno giovane, l’altro più vecchio con faccia da sindacalista.
Mi complimento per il museo. Ma, non è loro e quindi, non gliene importa nulla.
Alla mia domanda su chi produce le maschere, mi dicono di andare giù in paese dove ci sono i negozi di souvenir.
Mi sto per arrabbiare, e dico al giovane, che se prova ad ascoltarmi forse comprende la mia richiesta. Stizzito, mi risponde che le maschere le fanno a Penia, pochi km lontano. Corro in albergo prendo la macchina e vado a Penia. Entro nel bar che mi è stato indicato.
Penso, se prendo qualcosa, magari, saranno contenti di darmi qualche informazione.
Mentre sto per chiedere alla signora di farmi un caffè, noto su un lato un tavolo con tanta insalata, un vecchio e i due nipoti che si sono messi a tavola per il pranzo. Mi coglie una nostalgia infinita, per ciò che di più caro esiste. Chiedo alla signora se posso mangiare anche io e che non voglio più il caffe. Rimango in disparte per poterli guardare, e a distanza mangiare con loro.
Sono seccato di apparire come un turista per l’ennesima volta. La sala è vuota, tranne una donna sulla quarantina, che sola come me, ascolta la musica in cuffia.
Pochi km più in là, la gente si massacra per prendere lo skilift. Mentre mangio, cerco con gli occhi tracce di maschere, ma non ne vedo. Forse ho sbagliato posto. Alla fine deciso mi avvicino al bancone e chiedo informazioni. La signora mi dice che quelli che fanno le maschere lavorano tutti negli impianti di risalita, e che non troverò nessuno a casa, fino a sera… Buco nell’acqua.
Esco per fare due passi, e divento all’improvviso, quello che era entrato poco fa, nel bar alle mie spalle.
La signora che stava al tavolo di fronte, uscita anche lei, mi indica la casa di uno che fa le maschere.. Andrea il più bravo. Abita nella casa celeste alla fine del paese. Arrivo fin lì dopo aver attraversato l’antico borgo, e non trovo nessuno. Vedo una cantina aperta, dalla quale esce il fumo dello stallatico. Qualcuno spala dentro. Busso e propongo la stessa domanda.
Mi dice di andare a trovare Enzo che sta in quella casa laggiù, vicino al ponte di legno sul canale, oppure da Andrea in piazza a Canazei, di fronte a San Floriano.

Vado da Enzo, suono al portone, risponde al citofono e mi butta giù senza attendere che io riesca a dire qualcosa di convincente.
Non so cosa fare, se suonare di nuovo, o attendere o andare via. All’improvviso si apre il portone dello stabile, e si affaccia un uomo minuto e appuntito come una matita. Si appoggia allo stipite della porta a braccia conserte, con il fare di uno che vuole provocare. Solo allora capisco di essere su una strada complicata e piena di prove da superare e mi chiedo, perché dovrebbe essere diversamente.
Gli dico che sono un fotografo, e lui mi dice, ah…lo so bene! Senza accennare un sorriso. Venite tutti da me, prosegue, che sono il presidente dell’ associazione delle maschere, ci chiedete di fare le foto e poi scomparite. Uno, lo scorso anno, aggiunge strafottente, è venuto, ci ha fatto le foto e poi ha mandato qualche scatto, e ci ha detto che se volevamo il resto, le dovevamo pagare. Questa l’ho già sentita….
Poi mi dice, che ora le maschere non si possono vedere, perché sono tutti al lavoro, e che se voglio, torno nel periodo di carnevale. E due.
Gli spiego, quasi con reverenza, che sono venuto lì per via della luna piena di domani e che a carnevale non so se potrò tornare..
Ci scambiamo i numeri, abbozzo delle scuse a nome della categoria. Me ne vado da Andrea.
Fatto qualche chilometro, mentre cercavo di ricordare una casa che avevo visto all’andata tutta circondata da tronchi di legno, suona il telefono. Il presidente dell’associazione delle maschere di Penia, si era reso conto di avermi trattato male e mi vuole regalare un bel libro. Torno indietro, perdo la casa che volevo fotografare, e una volta ritirato il bel volume, ringrazio e vado da Andrea.
Ricordo solo il nome della chiesa. Parcheggio lontano e vado a piedi.
E’ già pomeriggio inoltrato. Lungo il cammino, una famiglia di napoletani mi ferma nei pressi di un giardino, in cui sono esposte delle opere artigianali in rame battuto e rivettato.
Si tratta per lo più di “tabernacoli” pagani, in cui sono raffigurati in maniera ossessiva animali in prevalenza galli e uccelli. Nella parte bassa ci sono delle macabre teste di bambola inserite sul corpo anch’esso fatto di rame. Appaiono essere dei pupazzi, simili a delle macumbe, più che a dei figuranti, o Lari. Credono i napoletani, che io sia l’autore di quella roba, e mi chiedono i prezzi. Mi hanno già seccato.

Rispondo in inglese che non parlo italiano. Arrivo alla chiesa e il negozio che cercavo, è chiuso.
Scorgo sul lato opposto un ragazzo sulla trentina. E’ molto alto. Indossa dei pantaloni di fustagno nero, di almeno due misure più grandi, e con una banda laterale ancor più nera.
Gli occhi cerchiati da un incarnato più chiaro. Come di chi sia solito proteggersi gli occhi, dal sole montano. Mani affusolate lunghissime. Un corpo e una ossatura esile e ciondolante, dentro vestiti grandi il doppio. Leggermente incurvato sulla schiena, tale da farlo sembrare quasi figlio di vecchi.
Lo apostrofo da lontano, mentre deciso sta per entrare nella porta di un albergo.
Mi guarda mentre seguita a salire quei pochi gradini che parano all’albergo, di cui ho capito, è il portiere. Mi fa cenno di avvicinarmi e di entrare e di seguirlo. Gli spiego cosa sto cercando. Mi dice senza parafrasare, di non andare da Andrea perché fa roba dozzinale, ma da Claus Soraperra.
Il nome mi piace, anche se so che non lo ricorderò con facilità. Mi spiega pazientemente, dove trovarlo e me lo scrive su una cartina, e mi da anche il suo numero nel caso io abbia problemi a trovarlo. Attraverso tutto il paese indeciso, se seguitare a dare retta a quella catena di
Sant’ Antonio, o riconoscere che sto perdendo il mio tempo sapendo per giunta, di potermelo permettere. Gli unici 4 giorni di vacanza, in un anno intero.
Aiutato dalla cartina arrivo a casa di Claus. La casa è tutta affrescata esternamente. Sono affreschi recenti che mostrano il papà di Claus, raffigurato insieme ad un noto fotografo delle Alpi, tale Dantone.
Il primo che immortalò queste montagne, su lastre fotografiche di vetro.
Dopo un periplo di scale, una ragazza mi apre la porta affacciata su odori di porri a bollore, e mi riporta di sotto, dove si trova la cantina di Claus. Questi è il figlio di un padre, famoso scultore locale, il quale mi dice che lo stesso, si è gravemente ammalato.
E’ tornato dall’ospedale il giorno prima, e non vuole vedere nessuno.
Gli spiego che non voglio disturbare, e il motivo della mia richiesta. Faccio uno sforzo ancora, cercando di aprire uno spiraglio circa le mie intenzioni, e gli spiego che fotografo nelle notti di luna piena, e che avrei bisogno di una bella maschera da utilizzare stanotte.
Come folgorato, zittisce e quasi toccandomi con la mano, e tenendo il braccio teso, sospendendo per qualche secondo il dialogo. Puntandomi l’indice, come mi conoscesse da una vita, mi dice, che la persona giusta è Fulvio. Abita nel paese dove sono alloggiato. O almeno molto vicino. Mi dice che Fulvio, è uno sciamano. Un personaggio del posto, e di chiedere all’albergo dove sono ospite affinché qualcuno, mi possa indicare dove vive, perché lui non lo sa.
Incomincio a nutrire qualche speranza, e al tempo stesso mi sento carico di quella stanchezza che partoriscono, a volte, i dubbi. Come se stessi forzando la mano. Decido che dopo il prossimo passo, mi fermerò qualsiasi esito negativo, mi avesse dato la ricerca. E’ ormai notte. Fila lunghissima di macchine per ritornare in albergo.
Arrivo che gli sciatori sono rientrati. Prima di salire in camera vado dal direttore dell’albergo, ringraziandolo per avermi indicato il museo quella mattina, e che quel primo passo mi aveva infine condotto a casa di Claus, ed è sottointeso che, ora stava a lui girare l’ultima carta.
Dal mio sguardo capisce che deve farlo subito e non domani mattina. Mi conferma che Fulvio lavora alle funivie, ma a quest’ora sicuramente lo trovo a casa. Ci vada direttamente, mi suggerisce. Preferirei chiamare, gli rispondo, visto che mi ero imposto di non proseguire di fronte a qualsiasi esito negativo. La telefonata avrebbe potuto lasciare aperto qualche varco.
Cerca il numero. Mentre parla, non posso fare a meno di pensare, che sta li in quell’ufficio dal mattino alla sera, e che è pieno di tic. Mi fa venire voglia di imitarlo, o almeno di provarci una volta in macchina o in camera. Per capire cosa si prova.
Mi scrive il numero, ma è mancino. Alcuni numeri sono scritti male e una volta provato a chiamare mi dice che il numero è inesistente.
Sono sul letto scoraggiato. Ormai sono le 18. Chiedo ad uno del gruppo, se mi accompagna a casa del tipo.
Se qualcuno, lungo la strada, mi desse delle indicazioni a voce, sicuramente non capirei.
Ho problemi di memoria, e la mia breve, è anche più corta. Poi non ho più gli occhiali e non ci vedo di notte. Uno di loro decide di accompagnarmi e di guidare. Accende il navigatore, ma non trova la strada. Penso tra me, che di sicuro ci sarà qualcuno che a quest’ora, porta a fare la pipì al cane. Appare a pochi metri una donna con un lupo al guinzaglio. Accostiamo e le chiedo se cortesemente, mi sa indicare la casa di Fulvio. Quello che fa le maschere. Mi indica quella finestra li… quella accesa. Non ci vedo, ma la vedo appannata, a poche decine di metri. Suggerisco a chi mi accompagna di accostare e di aspettarmi in macchina, e che poi lo avrei fatto entrare ad un mio segnale.

Penso che non ci si presenta sul far della notte, in due, a casa di sconosciuti. Suono.
Mi viene detto al citofono, stravolto da sinistri sfrigolii elettrici, di entrare e accomodarmi. Varco in un ingresso angusto, dai soffiti bassi e le cui pareti sono avvolte da decine e decine di pietre e di minerali. Un grosso baule di legno, chiuso con un lucchetto sulla destra, e dei gradini sulla sinistra, costruiti con sassi di fiume.
Dall’ alito caldo della scala, proviene un ciabattare in discesa, anticipato da un urlo..Arrivo !
Compare davanti a me un omino basso con dei lunghi baffi e pizzetto che ricordano Asterix. Rosso in viso e la cima della testa bianca. Tipica colorazione di chi sta tanto al sole con un berretto. Dentro una voce mi dice … ci siamo.
Gli spiego il motivo della mia visita. I suoi occhi si illuminano, e mi apre un baule pieno di maschere. Mi scuso per l’orario e gli dico che fuori qualcuno mi aspetta in macchina e che non vorrei fargli perdere tanto tempo. Mi dice di chiamarlo e di farlo entrare.
Andiamo tutti nel suo laboratorio pieno di ciocchi di cirmolo. Sgorbie, scalpelli e trucioli. Qualche figura abbozzata. Vorrei fermarmi a lungo.
Poi via nella cantina, dove tiene i diavoli vicino alla caldaia.
Per ultimo in cima alla scala, appesa ad un chiodo, la maschera di uno sciamano con la testa piena di piume di fagiano.
E’ lui. Ma ancora, non oso chiedere. Ci porta di sopra, dove probabilmente vuole sentirci parlare e guardare negli occhi.
Si entra in una stanza tutta foderata di legno e di affreschi su legno. Dietro la porta una stufa di terracotta grossa quanto un armadio. Si scoppia di caldo.
Gli spiego che fotografo spesso nelle notti di luna, e che sono alla ricerca di qualche artigiano del luogo, che mi possa prestare una maschera per fare degli scatti. Lui stesso, per me sarebbe stato giusto per le mie foto, e gli chiedo di scusarmi per la stranezza delle mie richieste.
Mi risponde che in ciò che chiedo, non c’è nulla di strano. Anzi.
Dimostra di sapere perfettamente, cosa mi piace e cosa no, tra le maschere che avevo visto.
Si alza e prende lo sciamano.
Poi mi dice: il bastone intagliato che hai visto di sotto non lo vuoi vero ? Si.. non mi piace rispondo… è troppo elaborato tanto che mi pare finto. Hai ragione, mi dice, anche a me non convince. Sapeva già tutto. Prende uno scatolone, ci mette dentro lo sciamano e la faccia di radici con una pelle di volpe .
Riportamele domani sera a quest’ora.

Ricordo che uscimmo da casa di Fulvio, per tornare in albergo, che era ora di cena. Sopra di noi, un cielo in transito e un infinito alternarsi, di nuvole e pallori. Dopo cena, andammo a fare le foto, all’inizio sotto la pioggia, e poi salendo fino a 1700 mt al Passo di Carezza, sotto folate di vento gelido misto a neve, e improvvise schiarite che facevano correre le nuvole stracciandole sulle creste.
La sera successiva, tornai alla stessa ora del giorno prima, a riconsegnare le maschere.
Gli feci vedere gli scatti della sera precedente, e ne rimase colpito. Mi disse di sentirsi poco bene, e mi chiese, se fossi in grado di camminare per un’ora nel bosco. Risposi, che se non si sentiva bene, avremmo potuto rimandare tutto, alla prossima volta.
Allora cominciò a raccontarmi di tutti i posti magici dei dintorni, dove saremmo potuti andare.
Presi nota.
Alla fine, prima di lasciarci, ricordo mi chiese cosa io avessi sognato la notte precedente. Nessuno di noi era stupito.
Gli dissi di aver sognato 10 navi che erano in fila, in attesa di attraccare al porto della mia isola.
Su di una, la prima, c’era mia figlia che non vedevo da tanto. Era dentro un sanatorio abbandonato, e la stavano per dimettere. Era guarita. Poi ci fu una seconda parte del sogno che non riuscii a raccontare.
Mi disse che le dieci navi, erano novità in arrivo e che non sapeva se fossero buone o cattive.
Ci lasciammo con la promessa di ritrovarci presto. Quando la betulla avrebbe cambiato la corteccia.
La prima volta che andai lassù, avevo 17 anni. Con il Club Alpino.
Avevamo le calze di lana lunghe fin sotto il ginocchio, sempre coperte di neve ghiacciata, che mettevamo ad asciugare sui caloriferi, insieme alle bucce di arancia.
E scarponi, pieni di grasso di foca.
Mia madre, si era fatta prestare per me, i calzoni da sci perché non potevamo comprarli.
Di quelli che avevano una fascia elastica che correva sotto la pianta del piede.
Una notte, per gioco, facemmo una seduta spiritica, e mi spaventai.
Ricordo che era una notte di luna come quella, e che ad un tratto scappai, e abbandonai il tavolo.
Avevo “chiamato” mio padre, e mi aveva parlato. Era morto da tre anni. Seduto in quel largo vano che, nelle case di malga separa le finestre di dentro da quelle di fuori, guardavo la valle sottostante sbandare, in qua e in là sotto la luce lunare.
Qualcuno mi teneva da dietro, stringendo il diaframma. Forse era mio fratello. Svenni.
15-04-2014
1. “Mamma, quanto rompi!”
“Te lo vuoi mettere in testa che voglio vestirmi come cavolo mi pare!?”
“Ma vuoi startene zitta una buona volta?”
“Adesso basta, esci dalla mia stanza! Esci, ti dico!”
Sono riuscita a metterla alla porta. Alla buon’ora. Da un po’ di tempo non riesco più a reggerla. Sul serio. Riesce regolarmente a farmi uscire dai gangheri. A me. A me che tutti dicono che sono buona come il pane. Sempre lì a dirmi cosa devo mangiare quanto devo studiare quando devo tornare chi posso vedere... E come mi devo vestire, soprattutto. Questa è una cosa che una proprio non sopporta. Se ha sedici anni per di più. Ripeto: sedici anni suonati e lei che pretende di trattarti ancora come una bambina. Anche se certe volte mia madre mi fa più pena che rabbia. Non ha fatto una gran vita, e adesso si ritrova lì, una vecchia di quarant’anni piena di frustrazioni. Ma che ci posso fare io se mio padre l’ha piantata quando ero piccola. E se quel marpione del suo attuale fidanzato –l’ho capito da come mi guarda le gambe quando lei non vede- ha moglie e figli. E se per tirare avanti ha ancora bisogno di mandarmi ogni mese a bussare a soldi da sua madre...
“No che non ti apro.”
“Perché sono nuda, mamma.”
“Si da il caso che nel frattempo io sia cresciuta, e non gradisca essere guardata da te, e tanto meno sia interessata ai tuoi commenti.”
“Più rompi e più farò tardi.”
Mi piace guardarmi allo specchio. Adesso. Prima mi facevo schifo, ma adesso, no. Anzi. Negli ultimi tempi sono aumentata parecchio di statura. Ma non di peso. E a quanto pare la cosa sta dando buoni risultati. Anche il seno non è niente male. Non è un affare da siliconate, ma ha una sua dignità, una sua suggestiva presenza. E poi la curva dei fianchi, la forma della labbra, l’intensità dello sguardo quando inclino così la testa e accenno questo tipo di sorriso. Per non parlare delle gambe, e di tutto il resto che c’è un po’ più in su.
Più mi guardo e più la mia esistenza mi sembra assurda, un autentico spreco. Tutte le mie amiche hanno risolto la questione da una vita. Tutte tranne me.
Che sembro fatta apposta per attirare gli imbranati. E i timidi e gli indecisi e i platonici. Col bel risultato di essere ancora vergine. Alla mia età. Probabilmente sono l’unica in tutto il reame: una rabbia!
“Ho quasi finito: adesso arrivo!”
“Va bene, mi metto quella rossa che mi ha regalato la nonna.”
Non mi costa niente sfoggiare la collana di corallo della nonna. Anzi. Avevo già deciso di mettermi in rosso totale: intimo, minigonna rigorosamente inguinale, calze a maglia, stivaletti, chemise, rossetto, orecchini, borsetta.
E come tocco finale questa bella bandana di seta.
Wow! Direi che ci sono discrete possibilità di dare nell’occhio. Si sa mai che sia la volta buona.
Vamos.
“Va bene, prendo un taxi, così faccio prima. Si, mi fermo alla solita. Certo che mi ricordo: Veuve Cliquot e Sacher. Non so quando torno. Ciao mà”
La nonna ricca abitava nella brughiera a nord della Città. Allora quella era una zona di villini isolati, molto distanti gli uni dagli altri, costruiti nelle radure di un bosco di latifoglie. Il taxi mi aveva lasciato a parecchie centinaia di metri dalla casa, perché a quanto pare il vento aveva sradicato una quercia facendola cadere proprio di traverso sull’unica sterrata di accesso.
Non era ancora buio e conoscevo la strada a memoria: perciò mi ero inoltrata di buona lena nel fitto del bosco.
L’incontro con Lui fu immediato e inevitabile, perché il suo cane, un grosso e giocoso lupo nero, venne correndo nella mia direzione. Lui fece altrettanto per impedire che mi saltasse addosso, ma arrivò con qualche secondo di ritardo: il suo lupo, dopo avermi buttato a terra, già mi stava leccando le gambe.
Era così alto, forte e deciso! Compresi subito che con le mie deboli forze di ragazza non avrei certo potuto opporre la necessaria resistenza ad un suo probabile tentativo di approfittare di me.
Con un secco comando mandò a cuccia il cane, poi si chinò piano su di me, distesa supina sull’erba. E già arresa, a quel punto.
Non capii ciò che mi disse, ma il suono vellutato della sua voce e l’intensità del suo sguardo percorsero il mio corpo come una carezza infuocata. Allora chiusi gli occhi e attesi che arrivasse il resto: il tocco delle sue mani, il sapore della sua bocca, l’odore della sua pelle. E, infine, la consistenza del suo desiderio...
2. “Ti sei fatta male? Hai battuto la testa?... No? E allora perché stai con gli occhi chiusi?... Aspetta ti aiuto a rialzarti... Ti fa un po’ male la caviglia? Allora può essere che cadendo tu abbia preso una piccola storta: mi dispiace molto... Dove stavi andando, se non è indiscreto chiedertelo?... Ah, da tua nonna: e dove abita?... Si, ho presente la casa, ci sono passato prima, non è lontana: senti, se vuoi, per farmi perdonare, ti posso portare da lei, in braccio; poi con un po’ di ghiaccio dovrebbe andare tutto a posto... Attaccati bene con le braccia alle mie spalle, che il tuo pacchetto lo metto nel mio zainetto... Ah, è una sacher: speriamo bene, allora! Andiamo Lupo! E guai a te se provi ancora a saltarci addosso, capito?!... Ma no che non mi pesi: sei leggera come una piuma...”
Si, leggera come una piuma e profumata come una rosa di maggio. E poi, ha un modo di guardare così dolce, così fiducioso... Pensare che dovrebbe essere arrabbiata con me per quello che le ha combinato Lupo, e invece... Dev’essere una ragazza davvero buona, un angelo. Anche il modo ingenuo con cui si veste: dev’essere talmente innocente da non rendersi conto che vestita a quel modo potrebbe stuzzicare le fantasie di qualche depravato. Povera piccina, senti ora come con le sue tenere mani cerca il contatto con la mia pelle: di sicuro ha bisogno di affetto, di protezione... Mi fa una tenerezza... mi fa... mi fa...
“?”
“!“
3. E’ buio. Strano che non sia ancora arrivata la piccola. Piccola, si fa per dire. Loro diventano grandi e noi diventiamo vecchie. Eh si, è il destino, la ruota del tempo. E non ci sono soldi che tengano contro la vecchiaia. Mi sono fatta tre volte il lifting, ma sembro lo stesso una tartaruga. Eh si, bisogna rassegnarsi, non c’è nulla da fare. Non ci resta altro che vivere di ricordi, si di ricordi e di silenzio... Eh si, di silenzio qui ce n’è in abbondanza... soprattutto se dimentico di mettere l’apparecchio, vecchia sbadata che non sono altro... La dentiera almeno ce l’ho? Si, almeno quella. Ché non mi piace che mi veda come un rottame... Forse è arrivata... mi sembra di sentire un rumore alla porta... Dove ho messo il bastone?
“Sei tu, tesoro?... No, non sei tu: ciao bel cagnolone, aspettavo la mia nipotina e invece sei venuto tu a trovarmi, bravo! Come mai sei da solo, ti sei perso nel bosco? Povero cucciolone, scommetto che hai fame, vero? Aspettami qui, che la nonna ti porta gli avanzi del pranzo di oggi, che a lei invece, purtroppo, di fame me ne è rimasta pochina...
Lo sapevo io che eri affamato! Mangia, mangia, che ti fa bene. Ah, vedo che hai la medaglietta: aspetta allora, che cambio gli occhiali e così vediamo se riusciamo a rintracciare il tuo padrone...
Allora...: “Il mio nome è Lupo: telefonare a Grimm, 575651”
E così il tuo padrone si chiama Grimm! Bravo! Grimm, Grimm: l’ho già sentito questo nome...Mah, forse sarà qualcuno che ho conosciuto in gioventù. Oppure è quel signore che...No, quello non si chiamava Grimm ... si chiamava Petersen, o forse Andersen? Niente da fare, non mi ricordo più niente! Eh si, è o un peccato invecchiare...Si,è davvero un peccato.”
Giuseppe Bettani
boscaiolo metaforico e non
nelle pianure del bergamasco
15-04-2014
Ore 22:00.
La giovane sul letto sudava freddo. La sua mano tremava.
– Non ce la faccio più. Non posso più sopportare. Quanto tempo manca?
– Poco. Manca poco. Ora calmati. Dammi la mano. Fidati di me.
Ore 02:40
– Ma credi che io muoia stanotte? Credi che non arrivi viva alla mattina?
– Sorellina. Sorellina mia... Ascoltami bene, tu sei già morta. Lo senti come sei fredda? Il tuo viso è giallo. È già da più di un’ora che il tuo cuore si è fermato. Ora calmati. Sono quasi le tre. Tu sei morta poco dopo l’una. Capisci?
– Oh, Dio mio, sono morta. Che sarà di me? Cosa devo fare, Marco? Cosa devo fare ora?
– Niente. Stai calma. Non ti serve a niente agitarti, va bene? Senti ancora dolore?
– No, non più.
– Vedi?
– Ho solo freddo, Marco.
– Anche quello passerà.
– I morti mi fanno paura. Come sto ora?
– Sei ancora molto bella. Eri la più bella della famiglia, di noi tutti. Ci hai lasciati così giovane. Povero papà, che ti adora tanto. Che ne sarà di lui...
Ore 06:40
Il vecchio è sulla sedia a dondolo, col volto nascosto tra le mani. La madre è in piedi al centro del salotto. Preme una mano sull’altra sopra il petto.
La figlia esce dalla sua stanza. Cammina insicura, è tutta nuda, e si regge a fatica sulle gambe fini e lunghe. I capelli le cadono ancora umidi sulle spalle. Attorno agli occhi e sulle guance, il giallo della pelle ha acquisito un tono grigiastro, come se qualcuno l’avesse schiaffeggiata.
– Figlia mia, ma sei nuda...
La madre fa un passo verso di lei, ma il figlio la blocca, trattenendola per il braccio. La ragazza si spaventa, si fa schermo con le mani, e poi, spossata, si siede sul bracciolo del divano.
– Mamma, lasciala. È morta. Guardala. È morta durante la notte, mamma.
– No! Non è possibile... Oh, Signore, non è possibile.
Il padre finalmente alza la testa. Ha gli occhi rossi e dilatati.
– Se fosse morta, come dici tu, ora non sarebbe lì seduta di fronte a noi, no?
– Oh papà. Mio papà... – dice la ragazza, con una tristezza senza rimedio.
– È una questione di poco tempo ora, papà. – risponde il ragazzo. Purtroppo è così. Fra poco verranno a prenderla.
– Marco, che faccio? – chiede lei, stordita.
– Torni a letto. Ti sdrai, e fra poco vengo a coprirti. E non ti alzare più, va bene?
– Sì.
– Hai ancora freddo.
– No.
– Ora vai.
– Ma mi porteranno via...
– Sì, devono portarti via. Però bisogna che qualcuno li chiami. Lo fai tu, papà?
Ore 10:25
Due uomini in tuta verde posano piano una bara di metallo rinforzato accanto al letto. La ragazza è sdraiata sotto il lenzuolo bianco, il volto coperto. Gli uomini alzano il suo corpo reggendolo per le ascelle e le caviglie, e rapidamente lo depositano nella cassa. Poi la sollevano per le maniglie e la portano verso l’ambulanza che li aspetta fuori. L’autista, sentendoli arrivare, accende il motore.
Il padre, attonito, osserva dall’uscio gli uomini che infilano la cassa nel furgone. Fatica a reggersi in piedi. Senza sapere bene cosa fare, alza la mano in un ultimo cenno di saluto.
– È finita, papà.
– Ma lei è venuta a parlare con me e con tua mamma stamani, non hai visto?
– Sì, ma era già morta, papà. Ero con lei nel momento in cui è morta, ma non volevo che sapesse. Non le ho detto nulla. Gliel’ho detto solo più tardi.
– Che disgrazia.
– Vado a vedere come sta la mamma.
– La mia bambina. Era così bella, così buona...
– È finita, papà. Sono andati. Vedi? È tutto finito. Non c’è più nessuno. Ora vieni.
Julio Monteiro Martins
15-04-2014
Calvino amava questo racconto dello scrittore guatemalteco Augusto Monterroso.
Quando si svegliò, il dinosauro era ancora lì.
È incredibile vedere quante possibilità aprono queste otto parole. Sogno o veglia? E il soggetto chi è? Magari il dinosauro stesso.
Tram
Finalmente. La sconosciuta saliva sempre a quella fermata. "Sorriso aperto, fianchi ampi& una madre perfetta per i miei figli" pensò. La salutò: Lei rispose e riprese a leggere: colta, moderna.
Si infastidì. Perché mi ha risposto, non ci conosciamo. Era un tipo formale.
Dubitò. Lei scese.
Si sentì divorziato. I bambini, con chi staranno?
Andrea Bocconi
in "Racconti di Fretta", Repubblica 1991
Una vita in 53 parole.
La forza dei geni
Tutti invidiavano Yang Seng, segretario del partito in un paese della provincia di Yunan. Era affabile con tutti, però rigido e severo nell'applicazione delle direttive demografiche del governo. Vigilava che i matrimoni si celebrassero tardi e che nessuna coppia avesse più di un figlio. A sessanta anni, dava l'esempio passeggiando per il parco con sua moglie Jiu Qing, di vent'anni più giovane di lui, e la loro unica figlia Fiore di giada.
Un giorno, tornando dalla passeggiata, incontrò sulla porta di casa le sue cinque concubine segrete, con tredici piccoli Seng, di cui era riuscito fino allora a tener nascosta la paternità fino allora.
Fu espulso immediatamente, però nessuno gli poté levare una profonda, segreta felicità:era riuscito a realizzare il desiderio atavico di moltiplicare la sua discendenza e si era assicurato una vecchia tranquilla.
Alfonso Colodron
"Relatos de un minuto", Editorial Arte y Locura, Madrid 1992
Una cultura e le sue contraddizioni in 137 parole.
15-04-2014
Perché scrivere? Perché leggere? A che servono le storie?
La risposta a queste domande sembra superflua sia per chi già ama le storie, sia per la grande maggioranza che si tiene a debita distanza da ogni forma di parola scritta, per mancanza di interesse, di tempo, di consuetudine.
Eppure io credo che la questione del "a che servono le storie?" sia assolutamente vitale, letteralmente una questione di vita o di morte, per l’anima come per il corpo.
Gao Xinjian, ancora stordito per l'inaspettato premio Nobel, ha dichiarato a France Press:
“ Questo premio è un segno particolarmente importante giacché io non scrivo per il mercato, per guadagnare soldi o per fare propaganda: fin da giovane ho sempre avuto la mania di scrivere, senza mai fermarmi, e ciò per via delle sofferenze del mio paese. Scrivere per me è sopravvivere. Anche durante il periodo più duro in Cina, ho continuato a scrivere di nascosto, sebbene non pensassi di poter pubblicare un giorno. Da allora ho imparato a non aspettarmi nulla dalla vita” … ”Scrivere per me è il solo modo per restare vivo.”
Le parole di uno scrittore, di un dissidente, di uno nato con il dono delle storie valgono anche per l’uomo comune? Io credo di sì, perché l’esperienza della sofferenza è universale (quella della gioia meno) e condividerla, leggendo o scrivendo o narrando, guarisce l’anima, dà un senso.
Ne trovo conferma e conforto nella testimonianza di Abdellah Ziou Ziou, uno psichiatra marocchino intervistato da Piero Coppo ad Essaouira.
Ziou, che nel 76 aveva partecipato all’incontro di Trieste organizzato da Psichiatria Democratica e dall'equipe di Basaglia, ha lavorato nell'Ospedale di Ber Rechid, il più grande del Marocco, con duemila degenti, di cui 1800 cronici, “ in una piccola città in cui l'Ospedale era la sola fabbrica che dava lavoro alla gente, fabbrica per fabbricare follia, e con l’equipe di medici che già c’era e il personale curante abbiamo fatto un progetto per umanizzare l’Ospedale. Ho contattato alcuni pittori, cineasti, poeti, scrittori: dei creativi, perché ero convinto che, per il fatto di essere dei creativi, avessero una certa disponibilità di ascolto della sofferenza…”
Questo è vero, ed è stato ampiamente dimostrato anche dagli studi sulla personalità creativa: più conflitti e più capacità di avere accesso ai livelli profondi, al processo primario, all’ascolto insomma, di set stesso e dell'altro. Ma vi è una testimonianza decisiva e sconvolgente in un'altra esperienza del dottor Ziou: “ da sette anni animo delle sessioni di psicoterapia di gruppo per i sopravvissuti di Tezmamat e kal Assan Guna, luoghi dove le vittime di tortura hanno passato venti, quindici anni di detenzione segreta; e questo lavoro con le vittime della tortura mi ha permesso di vedere che l’immaginario è un mezzo importante di resistenza. Per esempio a Tazmat c’erano due padiglioni di trenta persone: in uno ci sono stati ventotto decessi e nell’altro solo tre o quattro. Nel padiglione dove ci sono stati meno morti avevano adottato un processo di ciò che chiamo resistenza attraverso l’immaginario:recitavano brani di teatro, facevano pranzi di cuscus il venerdì nel loro immaginario: uno usciva e andava al mercato, l’altro tagliava i legumi, l’altro preparava la semola e poi mangiavano, c’era tra loro un narratore straordinario che raccontava le storie de Le mille e una notte, e tutte queste attività attraverso l’immaginario hanno permesso loro di resistere in quel momento così oscuro e difficile della loro vita.”
Sherazade stavolta era un detenuto torturato, che salvava la vita a se stesso e ai suoi compagni con le sue storie.
Io ho condotto per due anni un corso di scrittura creativa nel carcere di Arezzo, una vera esperienza sub e transculturale: il gruppo era omogeneo non solo per la sua condizione, ma anche per la bassa scolarizzazione: c’ era anche un analfabeta, che amava ascoltare le storie degli altri e dettare le sue all’unico in grado di capire e tradurre il suo dialetto molfettano.
Era certamente transculturale, con la presenza di almeno sei o sette nazionalità e un numero maggiore di etnie. Dell’esperienza ho scritto altrove. Al momento dovrebbe riprendere, quando i tempi burocratici del carcere lo permetteranno. Il successo con i detenuti può essere dovuto a tanti motivi, il più ovvio dei quali è che ogni attività proposta rompe comunque la monotonia del carcere. Ma ciò che mi ha davvero colpito è che un detenuto trasferito in un altro carcere mi ha scritto per chiedermi di continuare gli esercizi di scrittura, e si è unito a lui un altro ragazzo con cui non ho avuto mai contatto: ogni quindici giorni propongo loro un tema, con una piccola storia che lo accompagna. E poi aspetto le loro storie, con l’ansia felice del lettore che si lascia portare via.
Andrea Bocconi
15-04-2014
Quel giorno, l’11 maggio del ’47, l’Italia giocava contro l’Ungheria. Lo stadio Comunale di Torino era stracolmo. Quel giorno la Nazionale scendeva in campo con la seguente formazione: in attacco Menti, che giocava nel Torino, Gabetto, anche lui del Torino, e Ferraris, che, come Menti e Gabetto giocava nel Torino; a centrocampo Grezar, che era del Torino, Castigliano, anche lui del Torino, Loik, del Torino e Mazzola, il leggendario capitano Valentino Mazzola, del Torino; in difesa Ballarin, giocava nel Torino, Maroso, anche Maroso era del Torino, e Rigamonti, il centro mediano della Nazionale... e del Torino; in porta Sentimenti IV... Sentimenti IV giocava... nella Juventus...

Giocavano a Torino e erano tutti del Torino... o quasi... si, in fondo, anche la Juventus è di Torino, ma Juve e Toro non sono proprio la stessa cosa. La Juventus era la squadra della borghesia, dell’aristocrazia, dei ricchi... della FIAT, o meglio... dei dirigenti, dei proprietari, dei Padroni della FIAT. Il Torino era la squadra del proletariato, del popolo, degli operai... degli operai della FIAT. Anch’essa era perciò in qualche modo, una squadra della FIAT ma... come dire...non dei padroni ma dei lavoratori... dei turnisti, dei tornitori, dei verniciatori, dei meccanici...

Il portiere della Juve aveva un nome alto, elegante, raffinato: Sentimenti... e non Sentimenti e basta, ma Lucidio Sentimenti IV, aristocrazia e tradizione. Il portiere del Torino invece aveva un nome singolare, insolito, difficile da capire alla prima, facilmente storpiabile, deformabile, un nome da pronunciare con calma, scandendo ogni lettera, ponderando gli accenti. Il portiere del Torino si chiamava Valerio Bacigalupo. Intendiamoci, Bacigalupo era un grande portiere, un ragazzone con un colpo di reni formidabile che lo poteva far arrivare lassù, lassù in alto, proprio dove, oltrepassata la traversa, inizia il cielo...e poi, caspita, era il portiere del Grande Torino, il Torino che aveva 10 giocatori su 11 in Nazionale... tutti, tranne uno, lui, Bacigalupo.

Va beh, era solo una amichevole, non era mica un dramma ma... ma accidenti i suoi 10 compagni erano lì che giocavano, che si godevano i cori dei tifosi che per vederli erano saliti anche sopra i cartelloni pubblicitari posti sopra le gradinate... PAGLIERI PROFUMI recitava la scritta parzialmente coperta dalle gambe delle persone che erano salite fin lassù per godersi il Torino... pardon, la Nazionale.

Bacigalupo non riusciva a farsene una ragione, “perché, perché hai chiamato tutti i miei compagni, tutti, proprio tutti... e io... e io, adesso, cosa faccio? Quando i miei compagni giocano, gioco anch’io, sempre, è normale! E adesso!? Mister, siamo a Torino, io gioco nel Torino, tutti i miei compagni sono in campo, accidenti! Chiama anche me! Anche... anche se oramai sono già tutti schierati, in mezzo al campo, con quelle maglie azzurre, sono bellissime, mister ferma tutto, dai, corri in campo, gridalo “scusate, scusate una svista, scusate silenzio un attimo” e tutto il Comunale che si zittisce, tutti che ti ascoltano, tu sei Vittorio Pozzo, mister, ti ascoltano per forza... mister dai che aspetti, guarda che sta per iniziare, mister, l’arbitro ha già il fischietto tra le labbra, mister... mister il fischietto... mister... ha fischiato... è tardi... ormai è troppo tardi...”

Baci, come lo chiamavano a Torino, tanto non riusciva a darsi pace che c’è chi sostiene che a volte raccontava che Vittorio Pozzo, il commissario tecnico della Nazionale, poco prima dell’inizio della partita, fosse realmente entrato in campo per richiamare Sentimenti e sostituirlo con lui ma che, al momento in cui si era trovato a dover pronunciare il suo nome: Bacigalupo, si fosse tragicamente infrenato, balbettando sillabe indecifrabili per poi confermare in porta Sentimenti, solo ed esclusivamente per comodità linguistica. Ebbene sì, Bacigalupo si convinse di essere stato escluso a causa del suo cognome.
Per la cronaca l’Italia vinse 3-2. La Nazionale giocò la partita successiva il 9 novembre a Vienna, contro l’Austria. Portiere: Sentimenti IV; e quella ancora successiva a Bari, contro la Cecoslovacchia. Portiere: Bacigalupo. Bacigalupo!? L’Italia, vinse 3-1, ma Baci non era poi così felice... “ma Valerio, cristo!, sei in Nazionale!”, lo rimproverava Mario Rigamonti! “Qualche mese fa c’ero io, adesso ci sei tu, devi essere contento! Tutti sono contenti quando si arriva a giocare in Nazionale, ma ti rendi conto Valerio, la Nazionale, hai portato il muso lungo 7 mesi, adesso tocca a te!... guardami... Valerio... guardami...”...
“ Sì, ma io quel giorno non c’ero” ribatteva Baci “c’era tutto il Torino in campo, e c’era tutta Torino negli spalti, e Torino continuava anche fuori dallo stadio... Torino! Torino ovunque! Non ricapiterà mai più, 10 giocatori su 11, non ricapiterà mai più!

Il 4 Maggio del 1949 a Lisbona pioveva. Il Grande Torino doveva rientrare in patria, lo scudetto era quasi nelle loro mani, ma mancavano ancora quattro partite. All’aeroporto a salutarli c’era anche Ferreira. Il Torino era volato fino a Lisbona per rendergli omaggio nella sua partita di addio al calcio, e lui, lì all’aeroporto, dava l’addio a quei ragazzi. A Lisbona quel giorno pioveva e dei nuvoloni bassi schiacciavano il cielo. Il volo charter G 212 della LAI, con a bordo 19 giocatori, i tecnici e tre giornalisti, partì alla volta di Milano. Poco prima di atterrare alla Malpensa, il pilota comunica un cambiamento di rotta, si tira dritto fino all’aeroporto di Caselle, Torino. “Non ricapiterà mai più, 10 giocatori su 11, non ricapiterà mai più” pensava Baci quando alle 17.05 l’aereo del Grande Torino andava trasformandosi in una enorme palla di fuoco schiantandosi sulla collina di Superga. “10 giocatori su 11, non ricapiterà mai più”.
Luca Baglioni
15-04-2014
Sfoglio la bibbia: Vogue. Cinquecento pagine per ottocentotrentadue grammi. Quaranta percento di pubblicità. Quaranta di servizi fotografici. Venti di parole. Si rincorrono articoli sulle diete e quanto sarebbe bene farle per le formose donne italiane. Articoli sul sesso e quanto è giusto rinunciarci se non si è provvisti di una massiccia dose di biancheria La Perla e guepiere Chanel. Ci sono solo modelle, alte e belle. Modestamente modelle.
“Che fai, scendi?” mi urla Marta. Non rispondo. Sarebbe come dire ad un analfabeta che la prima vocale è la “a”. Semplicemente non capirebbe. Marta però non si arrende: continua a urlare. Al terzo richiamo non resisto. “Arrivo, ma calmati”. Allora minaccia qualche parola veloce e poi si allontana. Sento i tacchi di legno che si muovono sulle mattonelle di cotto. Il cotto toscano non mi piace, ma Marta si ostina a dire che è proprio una bella cosa, è una cosa da ricconi, precisa, avere un cotto invecchiato naturalmente nello sgabuzzino per la domestica. Io non ho mai voglia di discutere con lei così finisce che sto zitta e che lei dice che ha speso settecentomila lire per dieci metri quadrati mica perché è scema ma perché il cotto invecchiato naturalmente è il must di stagione. Mi arrendo presto alle sue parole. Lei così si sente fiera. Io, tranquilla. Ultimamente la sopporto poco. Dice che dovrei uscire di più e cambiare ragazzo. Che uno più ricco e meno silenzioso sarebbe meglio del mio solito musone. A volte credo che abbia ragione, ma la maggior parte delle volte non lo ammetto. Detesto farlo.
Scendo dalle scale senza affrettarmi. I miei piedi aderiscono perfettamente al parquet caldo. Mi sento una rana, una di quelle che sta ferma al sole e si gode i raggi. Le invidio, io, le rane.
- Senti, ma cosa avevi da urlare tanto?
- Ha chiamato Valentina. Le ho detto però che stavi a letto. Richiama.
- Quanto tempo fa?
- Ora.
- Voleva?
- Boh. Credo dirti qualcosa a proposito di martedì, o forse. Senti, chiamala e basta. Non me lo ricordo.
Marta oltre ad essere una presuntuosa aveva una memoria terribile. Mia madre diceva che era colpa dei due pacchetti di sigarette che si fumava al giorno. Io dicevo, invece, che era semplicemente cretina. Spesso litigavamo sul suo quoziente intellettivo ma non arrivavamo mai ad una vera e propria conclusione: ognuna di noi restava, imperterrita, del suo parere.
- Ha chiamato anche qualcun altro?
- No. Nessuno. Ma, tanto che ci sei chiama anche tua nonna. Sai quanto si senta sola ultimamente.
- Uhm.
Alzai la cornetta. Le dita facevano meccanicamente il numero di nonna Iolanda, quasi mi sentissi in debito. La voce stridula e dall’accento profondamente palermitano di Caterina rispose. Blaterò qualcosa sulla casa e che mia nonna era alla votazione e che si era candidata. Per un po’ riuscii a seguire poi mi persi nella sua voce. Nella ritmica alternanza di tempi e cadenze. Vocale aperta, consonante a mezza bocca. Quando riuscii a riprendermi e chiedere “Nonna?” il telefono rispondeva, maleducatamente: tu, tu, tu: aveva attaccato. Pensai di rifare il numero. Poi mi dissi che sarebbe stato inutile: nonna non c’era. Probabilmente era ad una di quelle stupide riunioni del volontariato. Quelle dove tutte le ricche vecchie del paese si riuniscono. E discutono. Parlano dei poveri e inventano sempre nuovi modi per aiutarli. Alcune fanno poi dei bei centrini di merletto, convinti che quando non hai che mangiare, se almeno hai un bel centrino bianco neve da guardare, ti senti meglio. Li trovavo divertenti i loro discorsi. Una volta, quando c’ero andata anche io alla riunione, al centro della discussione c’era se la pasta da consegnare ai poveri nei pacchi doveva essere Carrefour o Esselunga. Il prezzo, per l’identico peso, era lo stesso ma alcune contestavano che il grano di un determinato marchio non fosse realmente italiano, ma cinese. “E’ il grano dei gialli” aveva commentato in dialetto stretto una . Nelle sue parole non c’era né razzismo né polemica. Solo il desiderio, semplice e ridicolo, di dare una pasta capace di assorbire meglio il sugo; semmai ce ne fosse stato.
“ Per la maggior parte siamo vecchie – mi aveva detto mia nonna in quella occasione, come a volersi giustificare – e vedove. Trovati un marito. Hai capito? Trovati un marito”. Non avevo subito afferrato il nesso fra il marito, la pasta al sugo, e l’essere vecchia. Avevo però annuito: “Certo. Senza un uomo, una famiglia, non si può vivere” avevo poi osato aggiungere. Tastavo il compiacimento di mia nonna, con compassione.
Posai la cornetta: adesso era il turno di Valentina.
Proprio in quel momento stava alzando la testa dal cesso. Il vomito le colava dalla bocca. Prese un po’ di carta igienica e si pulì. Appoggiò la schiena al water. Chiuse gli occhi. Cercò, a tastoni, con la mano destra, il pacchetto di sigarette. Ne prese una , sempre tenendo gli occhi chiusi. Con la sinistra prese i fiammiferi. Accese.
- Vale casso ti muovi?
- Eh?
- Martina al telefono. Ti muovi?
La madre di Valentina, infermiera anoressica con extention nere su base castana, parla. La sento, benché tenga la cornetta relativamente 0distante dalla sua stridula voce. Ha trentasette anni ma non ha ancora capito che la “z” in Italia si pronuncia “z” e non con lettere simili alla s di stronza. “Casso casso sei in ritardo” ripete sempre, trascinandosi il suo grosso culo per la casa, associando spesso all’elementare espressioni banali completamenti. E’ convinta che le basi del mondo siano due: la puntualità e la “s”. Spesso, fra di noi, io e mia madre, ci chiediamo chi le abbia dato l’abilitazione. Ogni tanto infatti ha certe uscite che fanno paura, tipo: “Oggi mi sento anemica. Ho dovuto mettere su più phard del solito” o “Mi volevano dare la laurea, honoris causa, in medicina, ma ho rifiutato. Mi sembrava uno spregio verso quei poveri bambini nel mondo che muoiono di fame”. Quando ci chiedevamo così apprezzavamo realmente Valentina. Era oro colato, in confronto alla madre.
Valentina ha diciotto anni da due mesi. Capelli lunghi castani. Occhi marroni con striature verdi, come sottolinea ossessivamente lei. Non ha cervello e per questo i suoi quaranta chili per un metro e settanta non sembrano così pochi. Il cervello, infondo, pesa. Valentina scende veloce per le scale. La sento mentre impreca. Odia essere disturbata mentre fuma. La sigaretta in mano, la stringe fra l’indice e il medio. La cenere svolazza. “Chi cazzo è che rompe?” starà pensando. Probabilmente.
- Scusa. Sono io. Che volevi prima?
Sta zitta. Probabilmente non ha riconosciuto la mia voce. Ci mette sempre un sacco di tempo a capire che sono io, a chiamarla. Benché da quasi due anni la chiami tutti i giorni. Benché io sia l’unica a farlo, ormai.
- Ehi. Scusa non ti avevo riconosciuta. Sai, sono un po’ rimbambita oggi.
- Non ti preoccupare. Non è una novità.
- Come scusa?
- No, niente.
Chiunque vomitasse regolarmente dopo ogni pasto e prendesse dalle sette alle nove pasticche di lassativo, avrebbe dei problemi pari ai suoi. Che, di per se, erano aggravati da una stupidità genetica e da un particolare cattivo gusto nel vestire.
- Che mi dovevi dire?
- Ah, tante cose.
- Di urgente, dico.
- Ah. Volevo dirti, hai letto la bibbia?
- Fammi capire, mi hai chiamato per sapere se ho letto la bibbia?
- Certo. Che domande!
- La stavo sfogliando. Prima di Marta.
- Marta? Marta è lì? Pensavo fosse in America.
- Ma se ti ha risposto lei!
L’avevo messa in confusione. Mi sentivo leggermente in colpa. Adesso, per i prossimi dieci minuti, mi avrebbe chiesto scusa per la sua incapacità di associare le voci alle persone. Poi mi avrebbe recitato a memoria la poesia della povera ragazzina scema che aveva problemi di udito fin dalla nascita perché guardava i cartoni troppo vicini alla televisione ed era un po’ lenta di ragionamento, come amava ripetere lei, a causa dei power ranger. Non capivo mai cosa volessero dire quelle frasi, ma conoscendo i genitori sapevo che dovevo giustificarla. Almeno in parte.
“La bibbia per ora non l’ho letta. Adesso me ne torno sul letto, a sfogliarla. Più tardi mi sa che viene il dottore. Dopo credo passi mia zia. Dopo ancora mi vedo la televisione e poi me ne vado a letto. Domani ti chiamo quando mi sveglio. Ciao” dissi tutto d’un fiato sperando di aver risposto esaurientemente a tutte le domande, sempre uguali, che mi porgeva quotidianamente. Da circa due lunghissimi anni. La sentii mentre prendeva fiato. Alla fine, parlò: “mi mangio un panino. Cerco di non vomitare. Un po’ di tv. Il letto. Ciao”. Poi, attaccò. E so che anche lei, in quel momento, probabilmente, stava facendo lo stesso. Per un po’ mi sentii felice: eravamo in sintonia. Come la terapia diceva. Quando funzionava c’era sintonia, fra le due malate. La nostra mi sembrava solo semplice routine, ma non volevo fare la solita pessimista, come diceva la dottoressa Marchetti, quando andavamo da lei. Ci faceva spogliare. Pesare. E poi voleva che parlassimo in prima persona raccontando le cose che l’altra faceva. Era umiliante. Quello che per me aveva valore per Valentina non ne aveva. Quello che per lei era vitale, come dire di aver visto alla televisione un bambino più magro di lei, per me era una stupidaggine. Quando ero seduta sulla sedia rigida di plastica gialla pensavo a tutto fuorché alle parole di Valentina. Iniziavo a odiarla per quello che mi faceva fare. E odiavo anche la dottoressa, per il stupido esercizio che ci aveva assegnato. Avrei preferito, senza dubbio, tenere un diario quotidiano, come durante la prima terapia. Certo, non ero guarita ma almeno non mi ero sottoposta alle chiacchiere di una cretina patentata.
“Allora siete soddisfatte?” chiese poi, visibilmente disinteressata, la Marchetti. Parlava avvolta in un camice che le copriva la maglietta verde troppo attillata per le sue tette cadenti. Sembrava quasi che stesse per soffocare. Non risposi, mi limitai ad abbassare lo sguardo. Valentina iniziò un lungo monologo che, oltre a non avere senso, era indescrivibilmente noioso. Iniziò a parlare di quando sua madre aveva tradito il padre. Lui aveva letto una lettera che l’amante le aveva scritto. Aveva chiamato la moglie di lui per raccontarle tutto. Poi, aveva minacciato il “bastardo”, come lo chiamava lui. “Più ascolti e più vedi meglio è” aveva detto poi, alzando la voce, senza accorgersene. “Più soffri, meno perdoni” aveva risposto la moglie tradita, senza pensarci.
“ Vedo che i progressi sono notevoli” aveva continuato, questa volta sinceramente entusiasmata, la dottoressa. Bruscamente interrotta Valentina aveva perso il filo del discorso. La dottoressa aveva colto l’occasione. “Andate, è tardi” ci aveva intimato, indicando l’orologio a muro bianco e nero. Le lancette rosse segnavano le sette e dieci. Avevamo ancora cinque minuti per parlare ma, evidentemente, a lei non interessava. Ci alzammo. Ringraziammo con tutta l’educazione che ancora conservavamo. Uscimmo dalla stanza. Pagammo. Salutammo la segretaria, che portava addosso i segni della passata anoressia. Uscimmo in strada, per fumare.
“Non sto soffrendo” disse Valentina, mentre stavamo cercando un tabacchino per le sigarette.
“ Davvero?” chiesi subito io. Lei annuì. “E tu?” poi, disse. Volevo dire la verità, per una volta. Volevo dirle che avevo sempre mentito. Che continuavo a vomitare. A fumare. A bere.
Lei, sentendo il mio silenzio, aveva aggiunto, come per stringermi la mano, con le parole: “Le persone sono diverse. I tempi. Le educazioni. I posti.” Non avevo risposto, ma avevo annuito, come per farle capire che ero d’accordo e che le volevo bene. Davvero, questa volta.
Un ragazzo biondo ci offrì due sigarette. Disse che il tabacchino era troppo distante, per noi. Quando aveva detto “per voi” mi ero sentita morire. Una reietta, mi ero sentita. “Ho sbagliato percorso” avevo detto, mentre accendevo l’estremità della sigaretta rollata male. “Perché?” aveva chiesto Valentina dopo poco, più reattiva del solito. Non avevo saputo rispondere.
Camminammo a lungo sull’Arno quella sera. I motorini ci passavano accanto. Alcuni suonavano. I ragazzi ci guardavano. Non capivo il perché, ma mi piaceva. Mi piaceva essere osservata. Specie quando mi sentivo bene, bella. Camminando sul fiume mi sembrava di essere lontana un miglio. Da tutti. Non mi sembrava di essere sola, nel mondo di luci e di motorini che mi circondava. Nel mondo di ragazzi che mangiano pizza (cinquecento calorie) e bevono coca (centosettanta calorie per lattina). Ci passò accanto una macchina. Lo stereo al massimo suonava la Consoli. Era “fiori d’arancio”. La canzone preferita di Adelaide. Prima che.
Valentina sentendola si rattristò subito. Mi prese la mano. La strinse. “Ti capisco” mi limitai a dire. La sua mano strinse ancora più forte. Tornammo a casa mia.
Dormimmo insieme quella notte. Ognuna controllava che l’altra non andasse a svaligiare il frigo. A vomitare.
Dormimmo per tutta la domenica. Quando ci svegliammo accendemmo una sigaretta e fumammo del letto. Da poco aveva imparato a fare i cerchi con la bocca. La vedevo mentre si impegnava. Aspirava. Contraeva la bocca. Espirava poi piccoli cerchi, dai dubbi contorni. Il giorno dopo sarebbero stati cento giorni dall’esame. Saremmo dovuti andare in Piazza dei Miracoli per toccare la lucertola. Nessuna delle due ci credeva che avremmo potuto prendere cento. Infondo era matematicamente impossibile. Ci trascinavamo dalla quarta ginnasio massicce insufficienze contornate da incredibili lacune. Era un mistero, non solo per lei, che fino al quel momento ci avessero ammesse. “Che dici, ci segano quest’anno?” esordì poi lei, reggendo con la destra la sigaretta che si avvicinava al filtro. “Senti, se ci segano adesso giuro che li denuncio. Non puoi illudere fino all’ultimo due belle ragazze e poi ritrattare” dissi. “Semplicemente non puoi” ripeté lei, convinta. Prese un’altra sigaretta dal pacchetto. Se la mise in bocca e l’accese premendola contro l’altra, mezza spenta. Il mozzicone lo tenne in mano per un po’. Lo guardava con attenzione, come fosse intenzionata ad adottarlo. Prese il posacenere. Lo schiacciò su, con forza. “Però ne abbiamo fatte di assenze” aggiunse, dopo aver aspirato ancora. “Ma siamo state malate” mi affrettai ad aggiungere io. Ci guardammo. Ridemmo, a lungo.
Il giorno dopo fu una palla. Il Cosmi e il Marzi vennero sotto casa mia a chiamarci. Scendemmo dopo poco. “Ho una notizia sensazionale” esclamò subito il Marzi, il più cretino dei due, senza dire ciao o altro. A nessuna delle due interessava ma sapevamo che comunque ce lo avrebbe detto. Fingemmo interesse e lui spiegò, come stesse per snocciolare la più importante delle notizie. “Il Donati, quello di educazione fisica, è finalmente crepato”. Guardai il Cosmi, sperando che mi dicesse che era uno dei loro soliti e insulsi scherzi. Lui aveva gli occhi giù, come se non avesse mai visto le sue brutte converse rotte. “Come?” disse poi Vale. Raccontò quindi che il Donati voleva dimostrare a dei ragazzetti di quinta ginnasio che era capace ancora di fare i mille metri in tre minuti e diciotto. Si era dimenticato che soffriva di cuore. Ed era crepato, all’ottantesimo metro. Giù. Stecchito. Con la bava e il sorriso contratto. I ragazzini avevano pensato ad uno scherzo. Solo dopo un paio di minuti avevano realizzato. “E’ fantascientifico” precisai. “Non ci sta proprio che Rodolfo crepa nei mille metri” aveva continuato Vale. Invece era proprio così. Quello di educazione fisica, quello che offendeva i figli dei separati. Quello che era nato a Parigi senza mai vederla sul serio. Quello, era morto. “Almeno la pianterà di segnalarci sulla pagellina che non facciamo educazione fisica. E, soprattutto, questa è la buona volta che la pianta di darmi cinque alla fine del quadrimestre” dissi. Non mi vergognavo affatto, detto fra noi. Il Marzi e il Cosmi pensarono che stessi scherzando e che era il mio modo di affrontare la vicenda. Ma, per me e Vale era già finita. Il Donati era morto. Nessuno ci avrebbe chiesto quanto è lungo il campo di pallavolo o quanti anni può avere massimo un arbitro di calcio per lavorare. “Andiamo ché è tardi” aggiunsi. Salimmo sui motorini. Destinazione, Piazza dei Miracoli. Di gente ce n’era parecchia. Gente da tutta la Toscana e qualche probabile cento. Per lo più, guardando le facce, sarebbero stati settanta, al massimo ottantacinque. Punk. Freak. Pottini. Sembrava che fossero usciti tutti da un film di Muccino. Il che mi disturbava parecchio e non per l’essenza in sé di quei film, che sostanza non ne hanno, ma perché mi sentivo terribilmente scema a guardare una lucertola di pietra recintata. “Era meglio se ce ne stavamo a casa a vedere tutta la scena dalla telecamera su internet” ripeteva Vale traducendo alla lettera il mio pensiero. Una ragazza, alta e grassa, provò a scavalcare. Un poliziotto la richiamò e la scena della sovversiva finì lì. Parecchi ragazzi iniziarono a girare intorno al Battistero. Altri, a fare cento passi avanti, cento indietro. Alcuni gareggiavano per raggiungere le cento bestemmie, i cento rutti, i cento culi toccati. Noi decidemmo di raccattare cento sigarette. Arrivammo a sessant’otto un voto che, sinceramente, non ci sarebbe dispiaciuto. Verso le dieci ce ne andammo. Nessuna delle due voleva più essere palpata da viareggini maleducati che non riuscivano a coniugare un verbo e a parlare senza inserire “dela fia” o parolacce ben assortite. Andammo in un bar dietro la torre, di fronte all’ospedale. Camici bianchi affollavano il bancone. Sembrava di essere a Pasqua durante la settimana santa a Martina Franca. I vecchi e i bambini, allora, si vestivano di bianco e camminavano, scalzi, per la città. Bevemmo un caffè rigorosamente senza zucchero. Accendemmo l’ultima sigaretta. Fumammo, in silenzio, mentre qualcuno cercava di contare all’indietro partendo da cento.
Flavia Piccinni
15-04-2014

“Ma chi è Chet Baker?”
A questa inattesa domanda di suo fratello, Paolo esibì la stessa espressione incredula che apparve sulla faccia della madre quando lui, tanti anni prima, le aveva chiesto: “Ma chi è Mussolini?” Poi pensò che Andrea aveva qualche attenuante per non aver mai sentito parlare di Chet Baker; lui stesso aveva scoperto da poco che la musica nel mondo non gravitava necessariamente intorno al Festival di Sanremo. Una sera d’estate un militare americano, rimasto in Italia dopo la guerra, aveva fatto ascoltare a lui e a un gruppo di amici un disco che aveva appena ricevuto dall’America; il brano era “Sixteen tons” e aveva risvegliato in Paolo una mai sopita curiosità verso i filoni musicali d’oltre oceano.
“È difficile spiegarti chi è Chet Baker, forse la cosa migliore da fare e che io e te prendiamo la bicicletta e andiamo a fare un giro di Mura e vedrai che troveremo la risposta alla tua domanda.”
La proposta era caduta in un silenzio incredulo. Un ragazzo di diciotto anni non si porta dietro il fratellino, se non ci è obbligato. I genitori si scambiarono uno sguardo sorpreso, fu la mamma a rispondere, anche se nessuno le aveva chiesto niente..
“ Bene, ma tornate presto. Tu devi prepararti per il compito di greco, se non sbaglio.”
Ancora raccomandazioni, ma loro già scendevano le scale di corsa, facendo tremare tutto. Li inseguivano raccomandazioni inutili.
Le Mura di Lucca sono lunghe quattro chilometri, perfette per un po’ di allenamento, a piedi o in bici. Andrea spingeva forte per stare dietro al fratello: aveva una Bianchi Rossa, col cambio Campagnolo a tre rotini . La prima bici col cambio e ne abusava, cambiando rapporto in continuazione anche se l’anello sulle Mura era ovviamente tutto pianeggiante. Paolo invece pedalava con un rapporto lungo, da fondista, e gli stava avanti senza rendersi conto che il suo passo normale era troppo impegnativo per il fratellino, che però sarebbe morto piuttosto di dirgli : rallenta.
Fu un sollievo per Andrea vedere che dopo Porta Santa Maria Paolo si rialzava e pedalava senza mani..
“ Perché ci fermiamo?”
Paolo aveva lasciato la bicicletta appoggiata a un panchina e si era messo a parlare con due compagni di scuola. C’erano anche altri grandi.
“ Ragazzi - disse agli amici- questo è mio fratello, si chiama Andrea.”
Il ragazzino si sentì orgoglioso e smise di chiedersi perché si erano fermati. Tutti guardavano l’orologio e poi riguardavano il grande muro grigio di fronte, più alto delle stesse mura.. Il muro del carcere.
“ Zitti, zitti” fece uno.
Una nota tenuta scavalcò il grande muro : laggiù, là dentro, qualcuno suonava. La nota, ormai alta nel cielo cominciò a spandersi in tutte le direzioni in onde lente e lisce, ricomponendo nell’aria i frammenti di un’anima.
Paolo si avvicinò all’orecchio di Andrea: “è una tromba, Chet Baker, il più grande dei bianchi.”
Neanche a Messa la domenica la gente stava così in silenzio. Ogni tanto qualcuno in bici si avvicinava per capire quello che succedeva lì, poi se ne andava.
Andrea era così contento di essere con il fratello che non chiese mai di andare via. Quando finì e tutti presero le bici chiese al fratello : “ci torniamo ?”
“ Sì, ma non dire nulla a papà e mamma .”
Questo era un dono in più, un segreto da condividere. Era l’ottobre del ‘61. Uno di quei mesi con la nostalgia dell’estate . Il piovoso autunno lucchese quell’anno tardò, Paolo e Andrea fecero molti altri giri di mura in bicicletta. A casa Paolo suonava ad esaurimento la musica di Chet, così scoprì che oltre al suono della tromba aveva anche una voce, ma strana, diversa da tutti quei cantanti italiani mezzi tenori; sembrava cantare solo per se stesso con quella vocina che ti arrivava diritto al centro della malinconia. Sui giornali nessuno parlava più della grande tromba bianca. Andrea imparava i nomi di Charlie Parker, Dizzie Gillespie, Lester Gordon, Gerry Mulligan.
Un giorno , arrivati puntuali al muro della prigione, c’era una ragazza ad aspettarli: Anzi, ad aspettare Paolo. Era molto carina, aveva i capelli tirati dietro in una coda di cavallo e non degnò Andrea di uno sguardo. Si sistemava continuamente la gonna, guardandosi attorno. Forse aveva paura che passasse suo padre, o forse lo faceva così, senza ragione. Quando si sentirono le prime note di Almost blue fece un gridolino eccitato, ma era chiaro che si annoiava molto. Dopo dieci minuti propose a Paolo di fare un giro. Lui disse al fratello di aspettarlo e si avviò verso il baluardo.
Andra restò lì, furioso senza capire perché, con un vago struggimento che si intonava benissimo alle note di Chet. Anche il giorno dopo c’era la ragazzina, si ripeté la storia del baluardo e il giorno dopo ancora Andrea andò a giocare a pallone con gli amici del palazzo INCIS. Paolo poi non gli aveva chiesto di venire con lui.
Anche in casa cambiò musica, in Italia ora c’era il rock and roll, Paolo aveva comprato Ventiquattromila baci di Adriano Celentano, e Claudio Villa dovette dividere il regno con un certo Modugno. Si smise di ascoltare il jazz, con evidente sollievo dei genitori.
Poi cominciò a piovere, il lungo monsone autunnale freddo di Lucca, e a nessuno veniva voglia di gite in bicicletta o di pallone. Paolo passa la maggior parte del tempo al telefono, bisbigliando con voce bassissima . Andrea prese il suo primo quattro a latino e si innamorò senza alcuna speranza della Torciglioni. Non lo disse a nessuno.
Passò un anno .
- Vuoi venire al concerto ?.-
- Che concerto ?-
- Chet Baker. Ha finito la pena. Esce e fa un concerto al Teatro del Giglio.-
L’idea non piaceva molto a suo padre : era pur sempre un drogato. Ma il fatto che fosse al Giglio, e la lista dei notabili che volevano esserci fecero pendere la bilancia verso il si. Del resto si era disintossicato in carcere. A volte, le maniere dure.. diceva suo padre guardando la madre, sempre troppo morbida con i figli, secondo lui.
Andrea non era mai stato a teatro. La madre lo vestì elegante.
In prima fila c’era lo psichiatra che aveva cercato di curarlo, Lippi Francesconi. Era lui che lo portava tutte le sere dalla clinica Santa Zita al Bussolotto ,il night versiliese dove suonava . Si deliziava del suo Jazz fino a tardi e poi lo riportava in clinica. Quella maledetta sera d’agosto lo psichiatra aveva un impegno, Baker era andato da solo e si era fatto nel bagno di una stazione di servizio. Lo avevano arrestato lì.
Andrea guardava i velluti rossi e stava ben fermo sulla poltroncina, osservando tutto. Era l’unico ragazzino in platea. Ed eccolo , quella musica ora aveva un corpo e un volto, che le somigliavano. Un uomo piccolo e agile, sembrava uno di quei pugili bravi , che ci tengono a salvare la faccia. Ma il naso li tradisce. Molto tempo dopo, qualcuno gli avrebbe rotto tutti i denti. Facendo tacere la miglior tromba bianca per due anni.
Chet quella sera suonava come se non ci fosse nessuno, ma il suo magnetismo se li portava tutti dietro. Quando riconoscevano un pezzo, i fratelli se ne bisbigliavano il nome all’orecchio.
- meglio di prima-, sentirono dire a qualcuno dietro di loro-
Qualcuno indicava una bella donna con i lunghi capelli scuri, la sua donna, Carol.
Quando suonò My funny Valentine capirono che il concerto era finito . Nell’estate era finito anche il primo amore di Paolo, e c’era stata la maturità. I Beatles erano alle porte.
Erano grandi i fratelli. erano uomini nel 1988, quando una scarna notizia riportò che Chet Baker era morto ad Amsterdam, forse cascato da una finestra, forse chissà.
Andrea aveva telefonato a Paolo per avvisarlo: ti ricordi ?
Paolo prese il walkman, ci infilò il nastro di Baker e andò davanti alle mura del carcere, per sentirselo in santa pace sulla panchina. Quel giorno non c’era nessuno. Solo lui, Chet e My funny Valentine.

15-04-2014
Lo guarda, e vorrebbe riuscire a calcolare esattamente quanti giorni sono passati dall’ultima volta, ma il calcolo si perde nel giro dei mesi e degli anni. E invece lo vede come se fosse ancora bambina, assorto davanti alla bilancina dorata. C’era sacralità nei gesti di suo padre, quando apriva il cofanetto di legno chiaro e sollevava l’asta pieghevole e poi fissava i piatti – li osservava a lungo, per essere sicuro che fossero proprio in pari. Nel cofanetto restavano allineati, in ordine decrescente, i piccoli pesi. Pesava la polvere e i pallini, per le cartucce. Suo padre aveva mani sicure e precise, pensava, e poi mangiava la polenta scondita, senza gli uccellini in umido.
La guarda, e vede solo lei, anche se sono in tre, le giovani donne che la folla sospinge verso la piazza. Verso di lui. E’ invecchiata, pensa, ma negli occhi ha la bambina che sedeva coi gomiti sul tavolo davanti a lui e non riusciva a stare ferma, fino a che lui si arrabbiava perché il tavolo si muoveva e la bilancia non era precisa. E’ invecchiata, pensa, se ne è andata ma è invecchiata.

Suo padre ha ancora il fucile in spalla, con le canne che puntano il cielo. Lei si trova a chiedersi che tipo di cartucce ha sparato, con quel fucile, se le ha fatte da solo, quelle cartucce per ammazzare il nemico. Lei non voleva essere un esempio, voleva solo vivere la sua vita di ragazza, voleva poter ridere, qualche volta, anche se fuori i buoni lottavano contro i cattivi. Suo padre era uno dei buoni. Lei si trova a sorridergli, ora che si incontrano dopo tanto tempo, quanto esattamente non riesce a calcolarlo, ora che tutti intorno gridano e qualcuno la spintona e qualcuno sputa.
La guarda sorridere. Non è cambiata, non cambierà mai, pensa. Quello che succede intorno, non lo vede nemmeno. Crede che tutto sia un gioco. Le hanno portate qui per dare un esempio. Di lui la gente si fida. Se dicesse “questa è mia figlia”, se dicesse “questa è innocente”, nessuno protesterebbe. Ma lei non è innocente, pensa, se ne è andata per avere bei vestiti, ballare alle feste, chiacchierare di cinematografo. Non piange nemmeno. Aspetta e sorride.

La gente si fida di lui. Lui sa cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ora è giusto punire quelle tre donne bionde dello stesso biondo, che facevano la bella vita nelle case dei nemici, con le serve a fare i lavori e i cioccolatini sui tavolini da tè. Le ciocche di capelli cadono sotto le forbici, mentre la gente applaude. Lei è l’ultima. Suo padre le tira i capelli, per fare più in fretta, poi la spinge in mezzo alla folla senza guardare. Passa tra mani che picchiano, mani che strappano via i vestiti, mani che gettano fango. Poi la folla finisce, rimane solo il rumore, giù in fondo alla strada. Lui è di nuovo seduto davanti al tavolo scuro, in mezzo alla piazza. Si è tolto di spalla il fucile, lo ha poggiato davanti a sé. Solo adesso lei sente dei passi che la seguono, sta per voltarsi quando intorno al corpo e alla testa le si avvolge una coperta e la voce di sua madre sussurra il suo nome prima di fuggire.

Anna Vezzoni
15-04-2014

IL Padre : Ciao sono qui, vorrei parlare con te, ma sento che mi sfuggi, come al solito..
* La Figlia : Ma no non è vero, anzi sì… è che non sono abituata a parlare con te .
§ IL Padre : ti ricordi di almeno una volta che hai detto qualche cosa di serio con me ?
* La Figlia : di una volta me lo ricordo.
Quando ho capito che non ci sarebbe stato più tempo per parlare ho aperto il mio cuore. Ti guardavo mentre ti tenevo stretta una mano, quella libera dalla flebo.
Ricordo che era magra, bianca, con le vene evidenti .
Mi piaceva osservare le tue mani, mi sembrava di vedere le mie : uguali in ogni particolare e quella differenza che c’era, i mignoli storti, era stata colmata da due incidenti che avevano curvato anche i miei.
Le tue mani mi davano una sicuezza che non ho più provato.
Anche quel giorno di novembre cercavo la loro forza e quando sentivo che rispondevi alla mia stretta ricominciavo a sperare che non te ne saresti andato , per lo meno non subito.
Era novembre , c’era il sole e dal vetro della finestra, schizzato dalla pioggia del giorno prima, osservavo le cime degli alberi che avevano ancora qualche foglia .
Pensai che non avrei visto quei rami nudi.. non osai finire quel pensiero e lo scacciai concentrandomi sulla ricetta della torta di riso. Quante uova? .. tre , e il lievito ? non ci vuole..
pensare ai piccoli gesti quotidiani stupiva il dolore e mi dava respiro.
Ma non sempre funzionava, e quel giorno mentre pensavo alla ricetta della torta i miei occhi si riempivano di lacrime.
Le scacciavo, temevo che tu mi guardassi mentre piangevo. Sentivo la gola che si chiudeva nello sforzo e mi faceva male.
Ti guardavo e mi sembravi più giovane ora che la malattia ti aveva scavato la faccia, ma del resto avevi solo 56 anni ed io solo 28.
Non potei trattenermi :
“ ti voglio bene” ti dissi” anche se tu non fossi mio padre te ne vorrei perchè sei una persona speciale…”
“ Che fai dubiti della mamma o pensi di essere stata adottata?” dicesti con un filo di voce sorridendo “ e non mi fare quella

faccia stupita che mi fa ridere , sembra che tu abbia due anni, ma se mi muovo mi da noia il cannello del naso…”
E così risi anche io, una risata liberatoria come un pianto che sciolse il nodo che avevo in gola..
poi lasciasti la mia mano per riprenderla con più forza di prima come per farmi capire che comandavi ancora te e mi dicesti:
“ Anche io ti voglio bene Pentolino.. sei la più forte di tutti noi tocca a te pensare alla mamma e a tuo fratello, ci posso contare vero?”
“ Ma di che parli ..smetti.. scusa ma devo andare devo fare la spesa ci vediamo domani.”
§ Il Padre: modo poetico di mettere le cose,!
Non per sottolineare ma io stavo per tirare il calzino e te mi dici che devi fare la spesa….. e poi che ti sembra di aver detto mai con quel:“ti voglio bene “si dice anche al gatto!
senza contare quel ” anche se non fossi mio padre”… mi ci viene ancora da ridere…..ti sentivi profonda? ci davi dentro di amore cosmico ? o hai sempre avuto dei dubbi su tua madre ? quella santa donna. E poi ,già che ci sono, te ne dico un altra :la torta di riso non ti viene neanche tanto bene ….
*La Figlia : senti mi sento già abbastanza in colpa..
§ Il Padre: ecco finalmente l’hai detto !.. come se non ti conoscessi… ma non andò così quella sera..
*La Figlia: dovevo restare li quella sera , insieme alla mamma..
§ Il Padre : ma non ti ricordi che sono io che ho voluto che andassi a casa dai bambini?
*La Figlia: sì, ma dicevi per dire…
§ Il Padre: secondo te quel poco fiato che avevo lo sprecavo per dire una cretinata? No , dicevo sul serio ma te non hai mai creduto a quello che dicevo, vero ?
* La Figlia: certo che no, mi hai sempre raccontato delle storie improbabili !!
§ Padre: che soddisfazione ! eri quasi una donna e ancora credevi a tutto quello che ti raccontavo…. come mi sono divertito con te !
*La Figlia : non ero così tonta ! dei dubbi mi venivano.. ma poi mi divertivo troppo : chi me lo faceva fare di rinunciare ai tuoi racconti?!
ti ricordi quando dicevi di essere un guaritore e un giorno facesti veramente passare il mal di schiena a quel signore che ci ascoltava per caso ? gli imponesti le mani sulla schiena mettendolo a squadra nel bel mezzo del Bar Fappani … e la mamma che fingeva di non conoscerti? si vergognava ..però rideva anche lei..
§ Il Padre: la mamma era una donna perfetta… un pò precisa..
*La Figlia: e poi avevi delle uscite.. come quella quando la nonna raccontava dell’ alluvione a Firenze
“ Che tragedia” diceva piangendo “ la mia bella casa tutta allagata., I miei mobili, i miei vestiti…..”
e te che non ne potevi più versandole da bere dicesti
“Su, su non se la prenda Armida …e ora dopo tanta acqua ….un pò di vino !!”
“ sono astemia Io !”disse smettendo di piangere.
§ Il Padre: povera donna, e in quell IO c’era tutto il suo disgusto verso la mia passione per il vino e per me.. ma l’ho sempre sopportata perchè pensavo di morire dopo di lei e invece .. che fregatura !… ma che bei ricordi questi: sono fatti di allegria ! e ti ricordi quando arrivava Babbo Natale?
*La Figlia: e chi se lo scorda , mi facevi prendere degli spaventi tremendi e come ci ridevi….sadico… e stai ridendo anche ora !
Sai, papa’, oggi dovevo scrivere un racconto sui miei giocattoli e le prima cosa che mi è venuta in mente è stata la meraviglia che provavo a casa dei miei amici vedendo un trenino o qualsiasi altro gioco che funzionava : a me non andavano mai, o perchè ti piccavi di non leggere le istruzoni o perchè li rompevi con quelle manone … ma anche su quello ci si rideva , facevi una faccia quando annunciavi serio:
“ Anche questo è andato…”
§ Il Padre: tutto il dolore che c’è stato nelle nostre vite non lo vogliamo neppure nominare, vero? che privilegio saper ridere, a piangere son buoni tutti !
E non ti sentire in colpa se non sapevi parlare con me , anche io non ero un soggetto facile ma non sono le parole che contano piuttosto quello che si è e quello che si fa e te non mi hai deluso, mai.
* La Figlia: ti prego ripetimelo, spesso ho paura di non essere stata capita
§Il Padre: mi facevi arrabbiare ma ti capivo e se non fossi morto avremmo potuto riprendere il discorso interrotto quando ti sei sposata..
eri una bambina e proprio nel pieno degli anni settanta mentre tutti i giovani pensavano alla rivoluzione te decidi di avere un figlio : “ io sono la vera anticonformista” dicevi….
Ed io che ero un vero conformista ti urlavo “ te sei scema” “scema come quelli che vogliono la rivouzione : ma che anticonformisti siete solo scemi! Teste quadre !” …ma poi ho accettato perchè eri imaspettatamente felice con tuo marito e con i tuoi bambini… proprio te che a 16 anni ti eri dichiarata femminista convinta a 19 eri sposa e madre senza rimpianti ...che testa strana,, difficile per me starti dietro…
* La Figlia: anche te pensavi che le femministe dovevano essere pelose con i baffi e senza marito?
Essere femminista per me voleva dire avere coscienza di se e quindi anche sposarsi, ma non come unica via d’uscita ma come scelta…..
§Il Padre: ma figurati se ho voglia di parlare di questo ora..
senti , invece , piantala di guardare le mie foto con quell’aria triste …sì ho avuto una vita dura ma ora posso affermare che me la sono voluta così … ed è così che se la vuole tuo fratello. Te hai l’idea fissa di farlo cambiare, di vederlo sereno. Ecco il tuo punto debole: pensi che sia in tuo potere far felice la gente ma non è così che funziona. Fattene una ragione : non è un tuo fallimento..
*La Figlia: la fai facile , io ho fatto tutto quello che era possible ? non lo so. Chi mi dice che non posso fare di meglio , trovare strade diverse, parole diverse?
E poi già che se ne parla : sei te che mi hai detto pensa a lui …
§Il Padre: ma da chi hai preso ?? sei così testona.. anzi lo so ! dalla nonna fiorentina… sì , è vero, pensa a lui l’ ho detto e te ci pensi ma : arrenditi , non lo puoi forzare .
*La Figlia: sì ma non ce la faccio a guardare senza poter fare nulla.
§ Il Padre: e allora che c’entro io ? sembra che sia colpa mia ! questo è il tuo problema : vorresti migliorare la sua vita, e possibilmente quella di tutti , ma ,naturalmente, secondo quello che per te è buono e giusto. In pratica sei una gran rompi scatole !
Piantala e accontentati di migliorare la tua di vita.
Senti , si è fatto tardi devo andare a fare la spesa.
* La Figlia : trovane una migliore per salutarmi..
§ Il Padre : mi sembrava che ti piacesse come comiato cosmico…..

Giulia Flores
15-04-2014
C’è un gatto. Pelo fulvo. Ma i colori dominanti in quel quadretto pomeridiano sono altri.
Il giallo paglierino delle sterpaglie fritte al sole di fine luglio. L’arancione dei giubbetti degli operai che lavorano alla rotatoria laggiù in fondo, quella per salire a Montescudaio. Il grigio rovente dell’asfalto, il verde dei pini ai lati della strada.
Il tutto reso più opaco dalla polvere e dall’afa.
Un’Ape da rottamazione si ferma lento davanti alla fonte. Ogni tanto si sente un clacson di qualcuno che ha furia.
Ma chi ha furia vadi piano, direbbe Aldo, incurante della grammatica ma esperto di detti popolari. E soprattutto ostile dal profondo alle trombette degli automobilisti in ritardo.
Scende dall’apino e si mette lì, Aldo, appoggiato alla staccionata del fosso. Guarda tranquillo le cose attorno; i suoi quadretti soliti e rassicuranti, di ricordi da vecchio. DOM in honorem sancti Caroli dicatum, ad esempio. Che non sa assolutamente cosa vuol dire, ai tempi fece la terza elementare a Riparbella e poi nei campi a lavorare. Per lui quella è solo la chiesetta di Casa Giustri, e da lì parte la stradina per andare al podere. Fatto tante volte quel viottolo, a piedi, per andare dal fattore. E infatti la scritta non la legge, perché la vista non è più quella di un tempo, ma la ricorda bene lo stesso.
Guarda quel gatto. Morto stecchito. Nessuno ce lo leverà, tanto. Stasera c’è la finale del pallone e te l’immagini se la gente ha voglia di levare i gatti morti dalle strade. Per me può rimanere lì fino ai prossimi mondiali, pensa tra sé.
Dall’altra parte dell’asfalto, accanto a dove è lui, c’è la fonte. Acqua buona, e viene tutti i giovedì pomeriggio con il suo carretto a motore per riempire le sue vecchie bottiglie. Durano tutta la settimana.
Meglio che spendere soldi per l’acqua. Non sopporta di doversela andare a comprare in Coop, l’acqua. Ai tempi s’andava al pozzo, ma era a gratisse, dice spesso alla nuora e ai nipoti. Ora la fanno anche trepperdue, è una merce di scambio come altre, l'acqua. Che schifo.
Che ore sono? Non è ancora tempo di andare a casa. Ma guarda, una macchina nera parcheggiata dietro la chiesetta. Sembra che sballonzoli. Ci saranno due a fare le cosacce, pensa, tanto oramai puppe e culi si trovano anche sugli scontrini del pane. Buon per loro. Sorride.
Prima di compiere il rito dell’acqua il vecchio ha altri adempimenti cui dedicarsi. Intanto la consueta passeggiata tra i pini, lungo il fosso pieno di pruni. Cento metri e basta. Il fosso però è bello fondo. Due uomini ritti di sicuro. E c’è anche un po' d’acqua, probabile che sia di scarico, con dei pesci a nuotarci.
Chissà come ci sono capitati.
Passa la Sita. O è la circolare dei paesi? Insomma, un autobus.
Ad Aldo fa allegria il pullman. E per un attimo si mette a ricordare le gite di paese con la moglie, la Marisa. Quando stavano ancora a Riparbella, prima di trasferirsi al Palazzaccio. Lei voleva andare sempre ai santuari, e all’inizio lui la prendeva in giro. Poi aveva scoperto che da vedere c’era comunque, ci si divertiva uguale e più che altro si mangiava bene: preti e polli un’so’ mai satolli.
Ora ha l’Ape e viaggia da sé. Di Marisa tiene la foto nel borsellino della patente.
La tira fuori quando va al cimitero. Il lunedì. Ma non fa come gli altri che si mettono lì zitti e fermi a lustrare il marmo. Lui dà un bacio alla foto e poi la saluta a voce alta. E ci parla.
Il pullman è una Sita, va verso la Steccaia, e poi su fino a Volterra. Ecco, dice tra sé, anche a Volterra ai tempi ci si andava spesso. C’era l’ospedale meglio della zona. Però quelle curve sono assassine, boia.
«Dé», gli viene da dire a voce alta, «c’ho visto tante di quelle macchine fracassate che non si contano».
Ora c’è l’autovelox. In due punti. E poi ci fanno tutte queste rotatorie che la gente deve per forza andare piano.
La macchina nera parcheggiata dietro la chiesa se ne va. Non si accorge del gatto, ma almeno non ce lo rispiaccica. Gli operai del comune stanno sempre lì a lavoro. A ribollire al sole.
Ma ai pini ci si respira. Quasi si può dire che ci si sta bene. Aldo si mette anche a contarli, i pini.
Così, per curiosità. Tanto non ha nulla da fare. Il tempo scorre come gli pare, e quel pomeriggio va lento.
Minuto più o minuto meno, contare qualche albero non fa certo la differenza.
Senza dimenticare la prostata, e allora un poco più avanti c’è un po' di canne, per non dare troppo nell’occhio. Lì vicino alla rotatoria. Bello pisciare all’aria. In piedi. Rilassa.
Una macchina sbanda per un attimo. E’ montata sul gatto, ce lo vogliono proprio finire.
Sale il vento.
Aldo ha una camicia verde pisello mezza sbottonata, la maglia della salute che gli spunta da sotto e un paio di pantaloni marroni tenuti su con delle bretelle nere. Dà proprio l’aria del contadino.
E’ un bel fresco all’ombra dei pini, con questo venticello. Il sole sta calando ma è sempre parecchio alto.
Stasera andrò al circolino a vedere la partita, programma mentalmente. Scommetto che a vincere sarà l’Italia. Ci sarà poi anche Lapo, quel tonto, che si farà un bicchiere di vino ogni tre minuti. Per allentare la tensione. Ma poi a casa briao tegolo chi ce lo riporterà?
C’è anche che non è per niente vero che a invecchiare si diventa più furbi, pensa Aldo mentre per caso si guarda le mani grandi e callose.
Il gatto è sempre lì, tutto sbuzzato. Cuoce al sole e all’asfalto. Gatto grigliato.
Ad andare verso Montescudaio intanto nasce un po' di fila. Gli operai smontano e fanno un po' d’ingorgo.
Pomeriggio fatto di niente, come tanti e tanti altri dall’inizio dell’estate, ma implicitamente allegro.
Aldo guarda le macchine, come a voler partire con loro. Lontano lontano, ovunque va bene.
Ovunque è indifferente.
Prova a leggere le targhe, ma gli occhi ormai si rifiutano di piegarsi a richieste così difficili. E poi che gusto c’è adesso a leggere le targhe? Ai tempi era il passatempo più simpatico in autostrada: con le sigle delle provincie Marisa si divertiva coi bimbi a formare parole. E quando erano finite si inventavano.
Oppure Michele iniziava a dire «Dov’è RM?», «Dov’è BR?», «Ma VA vuol dire Vada?», «Perché solo le città grandi hanno la targa? Voglio inventare una targa apposta per Riparbella!»...
Ricordi, sempre ricordi. Ma cos’altro può fare un vecchietto come me, si lamenta bonariamente.
Ora i bimbi sono grandi e ci sono stati a RM, a BR e anche all’estero dove ci sono le targhe gialle e si guida dall’altro lato della strada.
Il gatto non ha bisogno di targa, sbuzzato nel bel mezzo della via per la Steccaia.
Già. Laggiù c’è la Cecina, e il guado. Ora c’hanno fatto il ponte, ma ai tempi si scendeva giù nel ghiaino e si passava da un ponticello che stava sommerso tutto l’inverno rendendo la strada inservibile.
Era una meta di scampagnate primaverili.
Erano belli quei tempi. Non si pagava l’acqua a peso d’oro e la gente sorrideva più spesso. O forse no, forse si sorride anche oggi e io non sono più nel giro... Risata sonora a quei pensieri, tanto non c’è nessuno a sentirlo. E poi, comunque, l’improvvisa esplosione di riso del vecchietto non può proprio disturbare. Risata amara sorta da tutte le ferite che in media si accumulano nella vita tanto quanto da quel passionale sapore che può incontrare talvolta chi ha imparato a gustarla, la vita.
Come le ciliegie sciroppate che faceva la Marisa, ricorda ancora Aldo tra sé completando il cerchio dei suoi pensieri esistenziali: quando si tirava su l’acqua rossa dal cucchiaino per berla piano dopo aver mangiato la ciliegia, pareva di sentire ogni volta un sapore diverso. Nuovo. Simpatico.
Forse la vita in quel momento, a due passi dalla rotatoria e mentre gli operai del comune tornano a casa tra i borbottii degli automobilisti infastiditi, ad Aldo pare proprio come un sapore dolce e forte sulle labbra, giocando col nocciolo di una ciliegia tra i denti e la lingua.
Via, le bottiglie. Vanno riempite, e poi si torna a casa.
Aldo torna all’Ape, prende le bottiglie vuote e ad una ad una, lento, le riempie alla fonte. L’acqua è fresca e pulita, prende il suo posto dentro la bottiglia senza brontolare e quasi contenta di far risparmiare quasi dieci euro al vecchio. Una bottiglia. Due. Dieci. Il sole picchia un po' meno ma in compenso passano più auto. Ventiquattro, e il lavoro di Aldo è concluso. Sistema le bottiglie dietro, nel piano rugginoso del suo glorioso mezzo di locomozione, si lava il viso, tanto ormai è già mezzo ammollato dagli schizzi fatti prima, e si mette le mani in tasca per cercare le chiavi dell’apino.
Il gatto è sempre lì.
Forse non è giusto. Anzi, sicuramente.
Nessuno si merita di esser schiacciato tutto un pomeriggio dalle ruote dei macchinoni dei tedeschi che vengono a colonizzare i nostri agriturismi, anche se hanno perso due a zero e se le tengono belle calde quelle reti spettacolari. Ma anche se non fossero tedeschi non andrebbe lo stesso bene.
Il gatto è morto, e dunque ormai ci può passare sopra un carrarmato. Ma non è bello. Fa un po' schifo a guardarlo.
Magari qualcuno ce lo leverà.
Magari un giorno qualcuno deciderà che le cose belle hanno più senso di quelle brutte.
Magari anche un vecchietto d’estate a poche ore dalla finale dei mondiali può dare una lezione al mondo davanti alla rotatoria per Montescudaio.
Nessuno lo saprà mai. Aldo toglie il gatto dalla strada e lo lascia tra l’erba alta dietro la chiesetta, si lava di nuovo le mani e torna a casa. Mangerà presto per trovarsi in orario con gli amici del bar e vedere la partita.
Non importerà a nessuno, no.
Aldo è felice. Comunque.

15-04-2014
Il gatto della signora Gertrude mangiava banane. Lei gliele tagliava a fettine sottili e gliele serviva su un piattino di porcellana decorato. Le bucce poi le imbalsamava. Si trattava di un’imbalsamazione dolce, a base di zucchero. Più che imbalsamarle le inamidava. Con zucchero e alcol e l’aggiunta di un briciolo di cera, sosteneva lei. Le bucce, così conservate, le architettava, servendosi di stuzzicadenti, dava loro forme di pupazzi e le teneva sparse per casa come soprammobili. La sua casa profumava, ammorbava addirittura di zucchero, un odor di zucchero tegumentoso, frammisto a quello inebriante, esotico_____giallo_____delle banane, con la scia pungente e soporifera dell’alcol.
La signora Gertrude era una vedova di mezz’età, con i capelli tirati indietro sulla nuca, gli occhiali da miope e il naso, che non era proprio un nasino, sempre rosso. I vicini erano abituati a vederla con l’immancabile grembiule annodato in vita , con le ciabatte nere e i calzini bianchi, corti, che le lasciavano scoperti i polpacci robusti. Qualcuno sosteneva che avesse dei figli che vivevano lontano, forse in America, forse in Australia. Con tutti loro aveva rapporti di buon vicinato, anche se era considerata un po’ stramba. Nessuno ci credeva davvero fosse il suo gatto a consumare quella gran quantità di banane le cui spoglie imbalsamate ornavano la sua casa. Si sussurrava anche che la signora Gertrude bevesse. Soprattutto per via del naso perennemente rosso. Lei asseriva di avere la sinusite e la rinite cronica. Qualcuno era arrivato a mettere in dubbio non solo che avesse dei figli, che non si vedevano mai, nemmeno in fotografia, ma addirittura che fosse vedova. Sì, si era mormorato che la signora non potesse essere vedova perché non sarebbe mai stata sposata.
Ma erano voci che correvano e passavano, che svolazzavano sulla placida vita tranquilla della signora Gertrude, che era una gran cuoca di dolci. Tutto il vicinato aveva gustato le sue torte ai mirtilli, le sue torte di mele, le sue torte alla crema con noci del Madagascar affogate nel cioccolato. Erano enormi le noci del Madagascar e avevano un sapore piccante che il cioccolato esaltava. Fra le delizie dolciarie della signora Gertrude c’erano anche i biscotti al maraschino e le ciambelle arroventate, che dovevano essere mangiate bollenti per coglierne l’amalgama di sapori: cioccolato e vaniglia, arachidi e pistacchi annegati nel rum . A pensarci era strano che la signora Gertrude non avesse fra le sue specialità dolci alla banana, vista la gran profusione di banane che consumava.
Fu poco dopo Natale che la signora Palmira, sua dirimpettaia, cominciò a parlare strano della signora Gertrude.La signora Palmira era una vecchietta sui settanta che viveva da sola, ma tutti i giorni aveva ospiti i nipotini, i figli della sua figliola Cesira. La signora Palmira prese a borbottare a denti stretti contro la signora Gertrude , e a sbraitare proprio , a dare in escandescenze quando le capitava davanti il gatto di costei. Il gatto della signora Gertrude si chiamava Calimero. Era nero, con magnifici occhi verdi , di corporatura robusta, di baffo sopraffino.. Era un gran cacciatore di topi e di uccelli, ma con le persone aveva sempre avuto un comportamento mite, sullo zuzzurellone affettuoso, perennemente in cerca di coccole da chicchessia. Era solito sdraiarsi a pancia all’insù anche di fronte a persone che vedeva per la prima volta. Così quando la signora Palmira cominciò a lamentarsi che quella brutta bestia del gatto della signora Gertude impauriva i suoi bambini, nessuno sapeva cosa pensare. Che la signora Palmira fosse uscita di testa? Lei si metteva a strillare ogni volta che scorgeva Calimero , e strillando ingiungeva alla signora Gertrude di tenere chiusa in casa quella bestiaccia che doveva essere proprio una creatura del demonio, siì, dannata era, terrorizzava i suoi piccini belli, li spaventava a morte, avrebbe finito per farli morire……… Ai vicini non sembrava però che i nipoti della signora Palmira fossero spaventati dal gatto. Quando lo vedevano gli correvano dietro, volevano giocarci, gli acchiappavano la coda, si divertivano a vederlo fare le capriole. “ Ma cosa farà mai il gatto di così terribile?,, si chiedevano, sempre più convinti che la signora Palmira stesse dando i numeri. Finalmente una sera, dopo un ennesimo violento alterco con la signora Gertrude, la signora Palmira, sulla porta di casa, aveva sibilato che quella bestiaccia si divertiva a giocare con pezzi del corpo umano. La signora Palmira si era portata una mano alla bocca dopo essersi lasciata sfuggire quella rivelazione, e subito era entrata in casa, sbattendo la porta. Il gatto che giocava con……….aveva detto con pezzi del corpo umano……. “Già, a me una volta ha pizzicato il naso,, , ricordò l’Adele. “ E a me ha morso un dito, un bel morso anche,, disse Aldo. “ Ma…..un momento, la signora Palmira , avrà mica voluto dire che si tratta di pezzi tagliati dal corpo umano?,, . “Via, che discorsi sono questi ? E dove potrebbe trovare il gatto pezzi di corpo umano?,,. Tuttavia più che inorriditi o preoccupati erano tutti quanti incuriositi, Provarono a chiedere, timidamente, alla signora Gertrude : non era possibile che il suo gatto, andando a frugare nei rifiuti, fosse capitato in qualche cassonetto di rifiuti ospedalieri e avesse arraffato qualche pezzo o pezzetto di corpo umano? La signora Gertrude aveva mostrato loro una faccia allibita, offesa :impossibile, il suo gatto non si muoveva dal giardino. Erano tutte frottole quelle della signora Palmira, invenzioni da vecchia strega maldicente, e tutto perché non poteva soffrire la sua adorabile bestiola. La curiosità ormai era forte, lasciarla insoddisfatta procurava un certo languore o pizzicore, una certa inquietudine via,e fu così che i vicini si decisero a mettere il naso negli affari della signora Gertrude. Decisero di spiarla. Per giorni, dandosi il turno, osservarono ininterrottamente la signora dalle finestre del suo appartamento, che era al primo piano. Le finestre avevano le tende, ma qualche millimetro di vetro rimaneva pur sempre allo scoperto. Inoltre, stando accostati alle finestre, era possibile intravedere anche attraverso le tende: si vedeva in bianco e nero, anzi in bianco e grigio, ma era possibile rendersi conto di quello che succedeva all’interno della casa. La vita della signora Gertrude si svolgeva regolare fra i lavori di cucina, le pulizie e l’imbalsamazione delle bucce di banane . Fu al quinto giorno di ininterrotta osservazione che i vicini videro qualche cosa di insolito. Di prima mattina la signora Gertrude sbucciò una gran quantità di banane che andò a prendere dalla cantina. E, prima cosa strana, non si preoccupò affatto di imbalsamare le bucce, che lasciò anzi sbadatamente ammucchiate alla rinfusa sul pavimento della cucina, tra il tavolo e l’acquaio. Dopo aver sbucciato quella gran quantità di banane la signora Gertrude cominciò a pestarle col mortaio, una piccola quantità alla volta. Via via che le banane , pestate, diventavano una pasta densa e gommosa, lei le metteva sullo spianatoio che aveva collocato di traverso alla tavola e le impastava, aggiungendo farina e uova. L’operazione andò avanti a lungo. Alla fine sullo spianatoio ce n’era una montagna di quell’impasto. Allora la signora Gertrude, dopo aver assaggiato un pizzicotto di impasto, si strofinò le mani al grembiule ed uscì dalla cucina, dirigendosi nel sottoscala. Quando ricomparve trascinava dietro di se’ un grosso sacco nero, di plastica. Il sacco era chiuso con un laccio annodato all’estremità. La signora Gertrude aprì il sacco e ne rovesciò il contenuto sul tappeto della cucina, vicino alle bucce di banane. Dal sacco scivolarono fuori, chioccando sul pavimento ________MANI: sì, avevano tutto l’aspetto di mani umane. Alcune grandi, squadrate, nerborute mani maschili, altre più piccole, affusolate, perfino paffute. Ce n’erano anche che sembravano mani di bambini. Dopo le mani uscì una gamba, tagliata all’inguine, una gran gamba pelosa, dal polpaccio muscoloso , con un grosso piede dalle dita massicce. Poi scivolarono sul pavimento piedi di diverse dimensioni. Piedi lunghi e flessuosi, piedi piatti, piedi tozzi, piedi con l’alluce valvo. La signora Gertrude capovolse il sacco e ne uscirono fuori occhi , orecchi, nasi. Tutto il materiale fuoriuscito dal sacco era, con ogni probabilità, quasi fuor di ogni dubbio, appartenuto a corpi umani. Certo, per esserne sicuri sarebbe stato necessario vedere quelle mani, quei piedi, quegli occhi e quei nasi da vicino, sarebbe stato necessario toccarli.
Dopo aver ripiegato il sacco, la signora Gertrude andò nel ripostiglio a prendere un’accetta dal manico robusto, la impugnò con forza e giù colpi decisi sulla gamba, finchè non fu ridotta a tante fette. Riservò lo stesso trattamento alle mani e ai piedi , che presentarono qualche difficoltà in più rispetto alla gamba, ma alla fine furono comunque ridotti in fette. La signora Gertrude aveva un’espressione molto concentrata quando alzava l’accetta per colpire, sembrava le si allungasse la testa, le si incurvasse la fronte dalla tensione. Presto al posto della gamba, dei piedi e delle mani ci fu un ammasso di fette di carne di varie dimensioni. La signora Gertrude prese dal cassetto del tavolo un gran paio di forbici e con quelle tagliò i nasi, tagliò le orecchie. Con un coltello affilato fece a fettine gli occhi. Quindi, servendosi ora delle forbici, ora del coltello prese a tagliare, a sminuzzare le fette di carne che aveva ricavato dalla gamba, dalle mani e dai piedi. Fu allora che il gatto fece la sua comparsa in cucina, si avvicinò voglioso a quel mucchio di carne, vi accostò il naso, allungò la zampa, ne afferrò un pezzetto che cominciò a spingere davanti a se’, rincorrendolo, afferrandolo e lasciandolo andare. Come se fosse un topo. Alla fine lo mangiò rosicchiandolo. Dopo di che tornò alla carica, rovistando fra i pezzi di carne, raspandovi, leccandoli. E la signora Gertrude gli diceva: ” Buono Calimero, su, fa’ il bravo che la mamma ha da preparare la pappa,,. Intanto raccoglieva con le mani quella carne sminuzzata e la incorporava nell’impasto di banane che stava sullo spianatoio. Alla fine dell’operazione distribuì l’impasto in venti teglie e cominciò a infornare.
A questo punto i vicini, oltre che stanchi, erano perlomeno preoccupati. Si domandavano a chi fosse destinato quel pasticcio di banane e carne umana che la signora aveva preparato con tanta lena. E anche non potevano fare a meno di chiedersi come quella benedetta donna si procurasse quelle mani, quei piedi……sì quei pezzi di corpo umano.
Sul far della sera videro arrivare nel cortile un furgoncino bianco , che sui due lati recava la scritta rossa SOS FAME e sul retro, in caratteri più piccoli, la scritta nera “popolazioni dell’Africa equatoriale”. “ Cerchiamo la signora Gertrude B.,, disse il giovane alla guida del furgone. Lo accompagnava una ragazza bionda, vestita di arancione. Gli indicarono l’appartamento e il giovane salì dalla signora Gertrude insieme alla ragazza. Poco dopo, quando uscirono, i due giovani trasportavano due pile di voluminosi pacchetti, accuratamente incartati di bianco e legati con un nastro azzurro. I vicini, esterrefatti, rimasero a guardarli a bocca aperta mentre depositavano i pacchi nel furgone. “ Ma……la signora Gertrude collabora con la vostra organizzazione?,, , ce la fece infine a chiedere Aldo. “Eh, la signora Gertrude, caro mio,, disse il ragazzo “è una santa donna. Davvero una collaboratrice preziosa, insostituibile_________se non ci fosse lei_________,,
“Ah, sicché vi fornisce alimenti? ,, chiese Adele. “Eccome, ma non solo. Lei non si limita a fornirci derrate alimentari. Lei il cibo lo cucina, amorevolmente, con le sue mani. Ed è una gran cuoca,,
“Oh, che è una gran cuoca lo sappiamo anche noi,, disse Bruno, deglutendo a fatica. “ E scusate_______come fa per_____per le materie prime, sì, per gli ingredienti dei cibi che cucina? Ci pensate voi a procurarglieli?,, chiese Susanna con un certo timore, chè intanto si diceva : “ chissà questi chi sono,, “ Macchè, la signora Gertrude è molto generosa. Pensa a tutto lei,, disse il ragazzo. Aldo, Adele, Susanna e gli altri si guardarono in faccia con apprensione.
Mara Masolini
15-04-2014
Sriram ha settantasei anni, insegna english conversation a Sarnath, nella scuola Alice Project ed ha partecipato al corso di scrittura autobiografica dle gennaio 2009

Quelli erano i giorni in cui potevi ancora vedere sula strada camion che andavano a carbone. Un inglese che aveva lavorato in India a lungo per il suo governo doveva tornare a casa , in Inghilterra. Vendette molte delle sue cose, inclusa una grande radio, che comprò mio zio. Per averla pagò una somma con cui avrebbe potuto prendere un discreto pezzo di terra. Comunque , aveva deciso di investire il suo denaro nella radio e questo gli portò molto più prestigio nel villaggio di un qualunque pezzo di terra.
Mio zio portò la radio a casa, ma non sapeva come metterla in funzione. Aspettò mesi perché un suo amico venisse dalla città per aiutarlo a mettere in funzione il marchingegno . Il giorno in cui l’amico di mio zio arrivò c’era a casa un’atmosfera di festa. La grande notizia della messa in funzione della radio si sparse come onde radio prima che la si accendesse. Anche i bambini venivano verso casa nostra, bilanciando sulle anche fratellini e sorelline ancora più piccoli. Si unirono alla riunione molto eccitati, pieni di aspettative. Come tutti gli altri, del resto.
Cinque o sei giovanotti andarono a prendere in un boschetto di bambù le due canne più lunghe che poterono trovare.
Le canne furono fissate sul tetto a ciascuno dei due lati della casa e un lungo filo metallico fu teso tra i due pali. Un cavo usciva dalla radio per connettersi nell’aria con quello fissato ai bambù. Un altro cavo partiva dalla radio per finire in una buca nel terreno. Nel piccolo mondo contadino , buche di quel genere si facevano per piantare un alberello, mai per seppellire un cavo.
L’amico di mio zio fornì la batteria della sua macchina come fonte di energia. E per fortuna che era venuto in macchina, altrimenti non sarebbe stato possibile accendere la radio, perché quel tipo lì andava solo con la batteria d’auto.
Quando tutto fu pronto, l’amico di mio zio girò la manopola, ma non un suono emerse dall’apparecchio. Di tanto in tanto mormorava “ stazione” mentre cercava di sintonizzare. A quel tempo, associavo la parola “ stazione” solo ai treni. Mi aspettavo di sentire il rumore tumultuoso dei passeggeri che salgono e scendono dalle carrozze. . Infine, quando un’eterica voce giunse dalla radio, portando il mondo nel mio villaggio, mi illuminai: avevo capito cosa era una stazione radio. I paesani che avevano aspettato così a lungo, eccitati, sobbalzarono a udire per la prima volta la voce disincarnata che usciva dalla radio- la radio che mio zio aveva preferito a un pezzo di terra.

Sriram Jaiswal
15-04-2014
Caprice
Diavolo d’un capriccio
Colle parole ho fatto un pasticcio
Palla di gomma balza e rimbalza
Din don, campanellino
L’estate che arriva, si vedono i prati, i fiori fiorire
Din don la palla rimbalza, voglio un canino
Voglio un amico, voglio un tesoro
Già cerco il mare, le onde baciare
Su un’isoletta me ne scapperò in fretta
I viaggi, l’amore, la piccola casa da costruire
Un letto, un camino e lungo il futuro vò tracciando il mio destino
Cresci, cresci in fretta, diventa una donna che il tempo più non aspetta
Rotola palla, rotola cane, rotola l’onda ed io che sto ad annusare
Assaggio divino, assaggio il buon vino, le belle giornate, l’età matura che mi viene a trovare
E faccio il mio ingresso nei miei quarant’anni e sento l’ebbrezza di luoghi distanti
Di nuovi approdi, di nuovi confini
E sempre vò avanti a balzellini!
Manuela Potiti
15-04-2014
Vedo la luna vedo le stelle
Vedo montagne di caramelle
Vedo le stelle vedo la luna
Vedo colore e tanta fortuna
Vedo che qui non c’è più nessuno
Vedo che invece di là c’è qualcuno
Vedo chi dorme tranquillamente
Vedo chi invece non dorme per niente
Vedo colline, montagne e mari
Vedo sapori, salati o amari
Vedo la gioia vedo il dolore
Vedo tristezza e vedo amore
Vedo due vite che van parallele
Vedo le api con il loro miele
Vedo animali in cielo e in terra
Vedo la pace e vedo la guerra
Vedo aquiloni e vedo aeroplani
Vedo tantissimi esseri umani
Vedo paesi, nazioni, città
Vedo di tutto, un po’ qua e un po’ là
E per non vedere continuamente
Chiudo i miei occhi e non vedo più niente
Smartina
15-04-2014
Infilo la chiave nella toppa. E’già a casa, seduto in salotto davanti alla TV. Guarda la solita, immancabile partita.
-“Ciao, è tardi. Dove sei stata?”
-“Sono passata al laboratorio, erano pronte le analisi.”
-“Analisi? Sta male qualcuno?”
La tua voce non ha nessuna inflessione.
-“Nessuno. Io sto benissimo, fin troppo…” Sorrido e gli vado vicino.
Silenzio. Ha capito.
Dopo qualche minuto riprende a parlare con un tono diverso, noncurante. Non mi guarda.
-“Giorgio ha organizzato una mangiata per domani, in quell’agriturismo alle spalle di Chiavari.”
-“Andrea, sai cosa sta succedendo? Vorrei che ne parlassimo.”
-“Non vuoi andare?”
-“Sto cercando di rimanere calma. Non esagerare.”
-“Mi sembra non ci sia proprio nulla da dire.”
Comincio a sentire il sangue salire al viso. Le orecchie mi bruciano.
-“Credi?”
-“Certo. C’è solo da sbrigarsi. Una volta fatto non ci si pensa più.”
-“Di che parli? Una volta fatto cosa? Chi non ci pensa più?”
La mia voce è alterata. Mi alzo e mi piazzo tra lui e la TV.
Andrea si sposta in modo da poter vedere lo schermo.
-“Ora cominciamo con le sceneggiate. Non essere ridicola.”
-“Voglio che tu mi dica che pensi veramente quello che dici!”
-“Non solo lo penso, ne sono convinto. Non c’è nessun’altra soluzione possibile. Capitolo chiuso.”
-“Perché? Siamo alla fame forse? Sei disoccupato? Non abbiamo una casa? Perché allora?”
-“C’è bisogno di un perché?”
-“Certo e di uno bello grosso anche.”
-“Questa casa è troppo piccola.”
Lo guardo sbalordita.
-“Stai scherzando spero.”
-“No affatto. E’ esattamente per tre persone, non una di più.”
-“Tu sei pazzo. Non viviamo in un monolocale ma in centotrenta metri quadrati. Trovane un’altra.”
-“Emanuele è grande. Abbiamo una vita tranquilla, organizzata bene. Non ci penso neppure a cambiare le mie abitudini.”
-“Ah certo le tue abitudini…farti i cazzi tuoi vuoi dire?”
Impassibile continua a fissare lo schermo.
-“Dai passa quella palla!”
-“Ti sto ancora parlando. Sono qui, mi vedi?”
-“A te piace complicarti la vita, a me no. E’ questa la differenza.”
-“No, fortunatamente non è solo questa. Comunque non ero sola quando è successo.”
-“Tu sapevi come la pensavo. Mi hai preso in giro.”
-“Quella presa in giro sono io, e non certo da oggi.”
-“Fa come credi, rimango della mia idea. Non ho voglia di discutere.”
-“Neppure io. Sono più cocciuta di quello che pensi.”
-“Sei solo una pazza masochista!”
-“Se non lo fossi non sarei certo più qui. Hai paura che ti rovini la vita?”
-“Tranquilla, non me la lascio rovinare ne da te ne da nessun altro!”
Non riesco più a trattenere le lacrime. Gli volto le spalle.
Sento che si alza. La porta sbatte. Il silenzio in casa è più grande
E’ passata una settimana.
Questa mattina mi toglieranno il bambino.
La sala d’attesa dell’ospedale è deserta, sono qui sola, aspetto che l’infermiera mi chiami.
Mi hanno detto come funziona. Poche candelette e tutto finirà lì, sarò libera da questo piccolo grande fardello.
Dentro sto morendo.
Tutte le mie lacrime, la stupida felicità che ho provato quando ho avuto la conferma di essere in cinta finiranno. Da cretina quale sono, ho sperato fino all’ultimo momento che Andrea mi chiamasse, dicesse che non dovevo liberarmene, che lo voleva anche lui questo bambino.
Invece mi ha lasciato sola e io non ho avuto la forza. Mi sento una merda, mi odio per questo ma non ho il coraggio di assumermi la responsabilità di una nuova vita, io, che non so quasi cosa farmene della mia.
L’infermiera mi ha dato una bustina e ha detto che devo metterla io.
Resto inebetita, tra le mani la possibilità di soffocare qualcosa che sta crescendo dentro di me.
Non dovevo essere io a farlo, perché non l’ha fatto lei, perché non viene qualcun altro a inserire questa maledetta candeletta????
Ma sono andata in bagno e l’ho messa. Tutto come previsto.
Poi mi sono distesa su una barella, nella sala dove si svolgono le lezioni di preparazione al parto. Che ironia. Foto di donne col pancione e di bimbi in braccio a mamme più coraggiose di me mi fissano dalle parti verde chiaro.
Non mi hanno dato neppure un letto, mi trattano con una freddezza che scivola nel disprezzo. Chi cazzo sono loro per giudicare?
Ho messo un assorbente, tra poco sarà nuovamente una donna normale, libera e vuota……
Hanno un bel parlare di embrione, io mi sento come se commettessi un assassinio. Ci riempiamo la bocca di termini scientifici, ma questo “embrione” sarebbe diventato un bambino e io lo sto uccidendo. L’ipocrisia di chiamare le cose con nomi diversi aiuta a scaricare la coscienza.
Il tempo passa e non succede niente.
Sarebbe proprio un bello scherzo se non facesse l’effetto dovuto. Se quel cosino fosse tanto forte da resistere e rimanere aggrappato a me a dispetto di tutto.
Chissà cosa sta succedendo là dentro, quali bufere stanno per scatenarsi. Non capirà nulla di quello che accade, si chiederà perché tutto intorno stia tremando.
Dicono che “il farmaco provochi contrazioni che inducono il distacco dell’impianto embrionale”, proprio così hanno detto.
Gli sembrerà di essere capitato in mezzo ad una tempesta e si troverà sbalzato fuori dalla nicchia dove si credeva al sicuro. Lui si fidava di me.
Se ne andrà in silenzio, senza clamore. Scivolerà via perché sente che non è voluto, nessuno lo aspetta, nessuno sorride pensando a lui, nessuno gli parla. Meglio tornare al nulla di prima, dimenticarsi, non esistere, quando chi ti da la vita non sa che farsene di te.
Mentre scrivo spio il mio corpo. Mi sento esattamente come questa mattina quando sono arrivata, non sta succedendo proprio nulla. Dalle finestre aperte entra il rumore della strada. Il grido di un’ambulanza rompe la monotonia dei suoni. Qualcuno là fuori sta soffrendo.
In questo stanzone, isolata da tutto, sto sdraiata su una barella con un lenzuolo sulle gambe. Sono entrati alcuni infermieri. Tutti sanno perché sono qui e io mi vergogno terribilmente. Mi sento giudicata e condannata. Sono io la prima che giudica e condanna.
Quanto ci mette a fare effetto? Perché non mi si torcono le budella e non sento dolori lancinanti? Questa immobilità e questo silenzio ora sembrano quasi innaturali.
Ciao bambino. Chissà cosa saresti stato? Maschio o femmina? Chissà che occhi, che capelli, che viso avresti avuto, se ti sarei piaciuta come mamma. Chissà che vita avresti vissuto e come sarebbero state le giornate insieme a te.
Saremmo potuti restare tuo fratello, tu ed io, se avessi avuto un po’ di coraggio, se non fossi fatta come sono. Scusami. Scusa la mia debolezza, il mio poco amore.
Credimi, non vale la pena avere una madre come me, non dispiacertene troppo. Non hai perso nulla.
Quello che hai perso sono i colori del cielo, l’aria, le nuvole, le guerre, gli odi politici, hai perso il sole, i fiori a primavera, l’AIDS, la pioggia d’autunno e il commercio di organi, la droga, la neve e l’inverno, la pulizia etnica, il vento sul mare e la sabbia calda d’estate.
In fondo ti sei salvato, l’hai scampata bella.
Hai perso la libertà di soffrire e di ridere, non hai potuto scegliere.
Hai perso la vita.
Ancora niente. Perché?
Cominciano i dolori, sono poco più forti di quelli delle mestruazioni. Tutto qui?
E’ entrata l’infermiera.
-“Come ti senti? Cerca di stare coricata, se dovessi cadere ci andiamo di mezzo noi.”
Nei suoi occhi non leggo né simpatia né comprensione. Mi porge sgarbatamente una seconda candeletta.
-“Metti anche questa, vedrai che te la sbrighi in poco tempo”
Come un automa ubbidisco.
Dopo qualche minuto si scatena l’inferno. Mi trascino in bagno. Qualcosa cade nell’acqua scura del water.
Eri tu quel grumo di sangue che è scivolato giù nello scarico di un cesso di ospedale?
Un attimo e non ci sei più. Non ho avuto neppure il tempo di rendermene conto.
Hai fatto piano, silenzioso e triste ti sei staccato e te ne sei andato per sempre.
Hai lasciato un vuoto dentro di me, vasto e silenzioso come lo spazio siderale.
Di colpo si è fatto buio, cerco di mantenere il controllo, per quanto possa ancora capire, respiro con affanno e tutto intorno gira. Riesco a trascinarmi in corridoio e a trovare la forza di chiedere aiuto. Arriva gente, medici e infermieri si muovono intorno a me.
Forse sto per morire, ma non mi importa più.
I dottori hanno detto che ho avuto un collasso, dovuto forse al dolore o forse al farmaco stesso.
Mi risveglio nel letto di una corsia. Mia madre è vicino a me e piange.
“Perché non me l’hai detto?”
“Perché avrei dovuto?”
Avrei voluto morire veramente. La flebo goccia a goccia allevia il dolore, vorrei rimanere in questa incoscienza dove non c’è neppure il dolore morale, invece torno alla vita pian piano.
E’come se avessi fatto un viaggio attraverso lo spazio sotto una pioggia di meteoriti e di stelle infuocate e fossi approdata di nuovo sulla terra.
Verso sera arriva anche Andrea. Ha portato Emanuele, forse per paura di quello che potevo dirgli.
-“Mi dispiace. Non volevo che succedesse niente di tutto questo.”
-“Davvero? Non mi sembrava che la mia salute fosse una tua preoccupazione.”
Mio figlio mi guarda con quei suoi occhi neri e brillanti. Occhi che ridono, come erano i miei, una volta.
-“Torni a casa presto vero mamma?”
-“Certo tesoro, per un po’ non andrò neppure al lavoro. Ce ne staremo tu ed io, stretti sul divano. Ti racconterò tutte le storie che vorrai.”
Emanuele mi sorride, mi abbraccia e si allontana la mano nella mano con suo padre.
Sono tornata a casa.
Dovrei sentirmi debole, invece ho dentro una forza che non mi aspettavo.
Ceniamo tutti insieme, poi Andrea si siede sul divano e accende la TV.
Chiamo Emanuele, andiamo nella sua camera e chiudo la porta dietro di noi.
Mi sono preparata queste parole, le ho pensate una ad una, cercando di non far trasparire la mia rabbia, il mio risentimento contro suo padre. Non c’è bisogno che sappia. Emanuele piange. Piangerà per qualche giorno.
E’ un mese che viviamo da mia madre, sono tornata nella mia camera da ragazza, questa volta però con mio figlio. Stiamo aspettando che Andrea trovi una sistemazione. Sembra non ci voglia più molto. Il rapporto tra padre e figlio non è cambiato. Andrea lo porta a scuola ogni mattina e lo accompagna agli allenamenti. Sono felice per questo.
La mia vita invece è cambiata.
Ho pensato che non avrei più sorriso, che non avrei dimenticato.
Sono tornata a sorridere, ma non ho mai dimenticato.
Clara Negro
15-04-2014
Se non vado errato, l’occupazione di Pisa cominciò quel giovedì 29 febbraio.
Stavo percorrendo la strada che lungo monte la collega a Lucca, quando verso le 7 di mattina, mi trovai all’ improvviso di fronte alla sagoma del battello sociale dei nostri invasori, sdraiato sulla pancia. Si ergeva ad una sessantina di metri da terra sovrastando le case, e percorreva l’ orizzonte, dal traforo che collega Pisa con Lucca, fino alla Telecom. Sembrava una baguette calpestata, biancastra e ovale, quasi del tutto piatta nel ventre, con i bulloni di giuntura delle lamiere bene in vista, e perché si svuotasse del suo esercito ci vollero quasi 28 giorni.
Delle semplici scale di corda pencolavano dalle migliaia di oblò che foravano la carlinga, e che con inesorabile lentezza, vomitavano uno ad uno il soldati di quell’ impero che da allora ci sottomette.
Bianchi, trasparenti e un pò cerulei, si sparsero a centinaia di migliaia in tutta la nazione.
Ebbi l’impressione che fosse finita per tutti, senza che potessimo ritenerci sorpresi.
E poi fu certezza.
Ad ognuno di noi ne toccò uno in sorte. Il mio mi raggiunse, avvicinandosi con un passo felpato e certo, mentre ero lì che guardavo la scena , quasi paralizzato.
Dicono che all'interno di quella cattedrale volante, ci fosse una unica grande sala, grande quanto la sua superficie. Al suo interno i soldati celesti in fila, e divisi da un largo quanto inutile corridoio centrale.
Al centro, in fondo, rialzata su 12 di gradini una grande piattaforma bianca, culminante con una grande spianata, al cui centro si stagliava una figura appesa a testa all’ ingiù coperta di miele.
Irradiava una luce propria, ed un silenzioso quanto amorevole sciame d’api la divorava.
A pochi passi da questa, un altra figura salmodiava in piedi mimando la sua stessa voce senza che s’ udisse parola. E a chi con deferente e giustificato timore vedeva la scena da lontano, sembrava che quella sorta di celebrante leggesse un piccolissimo volume che inforcava tra le mani scandendo un labiale esagerato e muto, di cui tutti gli astanti, sembravano attoniti capirne il senso.
Si trattava di una di quelle presenze che invocano e preludono spiegazioni urgenti.
Gli invasori ci liberarono definitivamente da ogni forma di demagogia.
Non c’erano più gli estremi perché la politica venisse praticata come un esodo estivo, etico e morale, ed in quanto tale venne censita tra i vizi capitali.
Molti furono i vantaggi che quella dominazione portò in quella regione.
Io stesso ero riuscito a creare una partizione dentro di me in virtù di questo.
La usavo per custodire intatte le mie intensità.
E spesso passavo le sere a ritrovare tutte le mie prime volte. Un cammeo dopo l'altro.
Sparirono tutte le forme di accidia esistenziale, e le Misericordie di paese.
Scomparve il senso di colpa che la macrobiotica induce per non essere stati migliori, almeno fin lì. Sparì la morte prima degli 85 anni se non volontaria.
E l’ amore tra generi diversi non fu più considerato un opzione di default.
La storia dell’ arte divenne l’ unica materia imposta agli studenti dai 10 anni in giù.
Successe un casino ovviamente.

15-04-2014
Robert Lewis Balfour Stevenson aveva smesso di viaggiare, perché stava morendo ormai da troppo tempo; la nera signora lo aveva scovato anche in quella remota isola samoana– ma l’aveva mai perso di vista ?-.
Gli camminava accanto da quando era un bambino, gli era madre e sorella e spesso gli parlava , ma solo all’inizio dei sogni.
Si fece portare la sdraio sulla veranda.
Fanny gli sistemò la coperta e gli portò un bicchiere di Bordeaux.
Il tramonto era intenso e rapido, non bisognava perderne un attimo. Lo guardarono in silenzio, tenendosi la mano. Pensò ai tramonti e alle albe scozzesi , visti dal faro di Monach, sull’isola di Shilley . A quel tempo suo padre sperava sempre che Robert continuasse la tradizione di famiglia. Robert portava il nome del nonno, grande costruttore di fari lungo le coste scozzesi.
Thomas Stevenson se lo portava dietro nei suoi giri di ispezione, non c’era mare grosso che potesse impedirgli di salire sui suoi fari e gli piaceva la sera versarsi un whiskey e berselo girando sul camminamento esterno.
“…e finalmente quando l’alba chiude la notte e cinge il semicerchio del mare, il faro pallido e alto nella luce sembra più bianco e spettrale che mai… …la notte è finita come un sogno… mentre, sulla torre bianca che si solleva alta con luce gialla nel vetro sbiadito, le lenti rotanti lampeggiano e scorrono e brillano fiocamente contro il cielo.”
Nessuno veniva più da tempo a chiedergli di raccontare delle storie al villaggio di Vailima, quelle storie scozzesi che i samoani amavano tanto, quelle storie per cui gli avevano dato il nome di Tusitala, colui che racconta le storie.
Il suo pubblico non sapeva leggere e non aveva nessuna preparazione letteraria, ma sapeva ascoltarlo attento e lui poteva sentirsi ancora una volta uno scrittore.
Ormai lasciava fare, ma non credeva più nelle cure, indigene o scozzesi . La cuoca Tahiri cucinava per lui il pesce nel cocco, gli dava i pezzi di carne più pregiati : ma lui mangiava pochissimo.
Da molto tempo non toccava la macchina magica, quella che gli raccontava le storie.
Un giorno Tahiri si era fatta coraggio e gli aveva chiesto
Tahiri si era messa le mani al volto, spaventata : aveva capito. E sapeva quello che succede quando gli dei tacciono troppo a lungo.
Ne parlò con gli anziani, che decisero di consultare il capo.
A qualcuno venne un’idea : forse può sentire la voce dei nostri dei, e raccontarci altre storie. Ma restava il problema della macchina magica, non potevano rubarla , e poi era sacra.
E sacra lo era per Stevenson, una Hammond che pesava un accidente, una follia portarsela in giro per il mondo, quella era roba da scrittori sedentari: ne era orgogliosissimo, era stato uno dei primi ad averla, mentre i suoi colleghi non si fidavano di quel marchingengno. A lui piaceva picchiare forte sui tasti. Veniva dal futuro quell’aggeggio e lui amava il futuro, del passato non gli importava niente.
Ainu il figlio di Tahiri aveva spesso portato Stevenson a pesca e gli voleva bene :era bravissimo col legno, gli dava un coltello e ti intagliava un delfino, una stella, il volto di una ragazza. Chiesero a lui.
Ci mise molti giorni, e lavorò in segreto. Aspettò che il sacerdote facesse la cerimonia nella notte di luna piena, legando uno spirito potente con un incantesimo.
Il sacerdote era soddisfatto, e anche il capo.
Gliela portarono di sera, con tamburi e fiaccole :
Stevenson guardava stupefatto questo piccolo monumento di legni, di tasti, di fili d’erba. Sembrava il sogno di una macchina da scrivere. Si tirò su a fatica, per ringraziare con dignità.

Ci mise le mani sopra, attento a non rompere i piccoli legni.
Sentii nitidissimo un suono di cornamuse da guerra , vide la gente del suo clan avanzare nella brughiera. Vide il grande faro di Monach, proprio in cima al monte Vaea. Indicò la direzione con la mano.
Thahiri piangeva piano, Fanny si torceva il fazzoletto tra le mani. Il capo assentì.
Otto giorni dopo, il tre dicembre del 1894, quaranta capi giunti da tutte le isole portarono a braccia in cima al Vaea Tusitala, colui che racconta le storie, e poggiarono sulla terra la sua macchina magica, ultimo dono dei samoani al loro grande amico.
Andrea Bocconi
Teresa Scarpa è Ainu, creatore della macchina che sa le storie
14-04-2014
E ottantuno ! E’ il numero delle edizioni del Siddharta per Adelphi, dal 73 . Herman Hesse ne sarebbe sorpreso ? Di certo ne hanno goduto gli eredi. Ma a queste dovremo aggiungere tutte quelle di Frassinelli, dall’uscita in Italia nel 1945: credo proprio che siamo oltre le cento. Adelphi, a cinquanta anni dalla morte dello scrittore, a novanta anni dalla prima edizione tedesca del Siddharta , ne pubblica una “nobile”, arricchita, scrive il risvolto di copertina , da “pagine di diario, lettere e riflessioni che ne illuminano aspetti poco o per nulla conosciuti; commenti e reazioni di scrittori e di critici quali Romain Rolland, Hugo Ball e Stefan Zweig; fotografie, riproduzioni di lettere e documenti che consentono di calarsi nel mondo e nelle atmosfere da cui il Siddhartha è scaturito.”
La bella traduzione di Massimo Mila per fortuna resta. Il libro Hesse lo scrive tra il 1920 e il 21, in un periodo in cui , già scrittore famoso, le sue posizioni contro il nazionalismo esasperato , antibelliciste, gli avevano creato molti nemici : riceveva lettere piene di insulti dai membri delle associazioni giovanili. Credo che Hesse cercasse rifugio e consolazione in questa storia che rappresentava l’espressione artistica della passione filosofica di una vita per i testi sapienziali indiani: il Vedanta, il Dhammapada, la Bhagavad Gita e tanti altri . Era nel pieno della sua maturità, a 45 anni.
Siddharta esce in Germania nel 1922. Credo che in Italia non esista un long seller che possa stare alla pari di questo piccolo, prezioso romanzo. Per tantissimi anni mi è piaciuto vedere il libro sempre nelle classifiche della narrativa straniera più venduta di Tuttolibri, mai al primo posto , ma costante nella diecina.
Io l’ho letto la prima volta a Orvieto, durante il servizio militare, nel 1971 : me lo prestò un amico , Piero Ferrucci, un po’ più grande di me e molto più colto, che curava la mia formazione con una sorta di biblioterapia. Quando arrivai in fondo ricominciai da capo e pochi mesi dopo, finito il militare, partii per l’India via terra, il primo di tanti viaggi che ancora continuano. Il bello è che l’unico viaggio in India di Herman Hesse, nel 1911, fu un fallimento : andò a in Malesia, a Sumatra e a Ceylon , l’odierna Sri Lanka, ma si ammalò di dissenteria e non raggiunse le coste dell’India come avrebbe voluto. L’Oriente lo impaurì, con le sue malattie, la povertà, la sporcizia . La sua India l’aveva in casa, nella biblioteca del nonno missionario e dei suoi genitori, nei piccoli bronzi, nelle stoffe dai colori brillanti, nelle memorie di famiglia. Era cresciuto respirando oriente , sognando lì una via di pace, lui che era divorato dall’inquietudine.
Alla fortissima aspirazione spirituale si accompagnava un’insofferenza per le difficoltà della vita quotidiana : i tre figli, la malattia della moglie. Sbaglierebbe però chi pensasse al suo Oriente solo come a una fuga, una pseudo sublimazione. Il protagonista del romanzo cerca l’illuminazione e nel suo cammino incontra l’amore sensuale, i commerci , le difficoltà del padre. E’ un cercatore solitario, tanto che, in uno degli episodi più belli, avendo incontrato il Budda , riconosce che è un perfetto maestro e, poiché non se la sente di seguirlo, non cercherà più altri Maestri. Ne troverà un altro , alla fine del suo cammino, inaspettato .
Un libro piccolo, quasi sospeso in un tempo e in una terra che forse non sono mai stati così . Ma quello che descrive è un paesaggio dell’anima, e questo fa sì che Siddharta riemerga a tratti come rigenerandosi in una nuova reincarnazioni : il libro è sempre quello, ma sono i lettori di epoche e culture diverse che lo fanno rivivere. Anche in India fu molto apprezzato.
A chi parla questo libro ? Negli anni sessanta la hippy generation, letto Siddharta , e magari il Libro tibetano dei morti, riprese in massa questo movimento migratorio che era stato di una elite : i Ram Dass, Ginsberg, Leary tornavano a Oriente, seguendo su altre piste le tracce di quei pellegrini che li avevano preceduti nel “ Pellegrinaggio alle sorgenti “, come il gandhiano Lanza del Vasto. Viaggi legati anche alle esperienze fatte con gli allucinogeni : i sadhu con i loro grandi chilom di ganja sembravano offrire sintesi interculturali interessanti.
Negli anni ottanta ricordo un mio giovane paziente, la cui malattia nasceva da una ricerca inascoltata di senso, che cominciò ad aprirsi alla psicoterapia quando gli dissi che sì, avevo letto il Siddharta, ed era stato importante anche per me. Era un giovane nato in un ambiente povero, ostile ai libri e cercava qualcosa di diverso dal mondo gretto che rideva dei suoi problemi esistenziali. Scoprire che altri avevano e avevano avuto le sue difficoltà e le sue aspirazioni, fu mezza guarigione. Io credo che Hesse parli agli inquieti dell’anima, a chi è curioso di avventure della coscienza, a chi ama quella radicale messa in discussione di sé che è un vero viaggio, dentro e fuori.
Dopo quell’isola di pace che è Il Siddharta, Hesse scrive Il lupo della steppa, avventura inquietante nei labirinti della mente, nata anche dalla sua terapia analitica : “quel piccolo pericoloso libretto”, lo definì un amico antropologo a cui lo avevo donato . La pace è finita , bisogna affrontare nuovi fantasmi, ancora più tremendi : ma le ultime pagine indicano l’uscita del labirinto.
Qualcuno discute la grandezza di Hesse , o trova il suo stile antiquato. Ma io credo che, nonostante il premio Nobel, Hesse sia letto non per come scrive ma per i temi eterni che tratta, e che la sua modernità consista in quell’individualismo inquieto, in quella ricerca senza patrie della verità , che è faticosa ma non può essere altrimenti.
Il risvolto di copertina suggerisce che possa interessare i letterati, i filologi, gli amanti di Hesse che lo hanno già letto : io mi auguro che ci siano in Italia molti sedicenni pronti a seguire Siddharta nel suo viaggio. E sarà l’ennesima reincarnazione di questo libro .
Andrea Bocconi
14-04-2014
Ci si occupa dei panda, della foca monaca, del passero marsicano . E le piccole librerie , non sono specie a rischio ? Hanno ancora un futuro ? Sono accerchiate da ogni lato : Amazon e IBS, gli e book, le grandi catene di cui sono proprietari gli editori : Feltrinelli, Mel books, Mondadori etc.
Sembrerebbe il momento di scappare , di cercare un altro lavoro : ma c’è chi un altro lavoro ce l’aveva, e ha scelto di fare il libraio .
Vi racconto tre storie : Marina e Gianpiero hanno fatto i camionisti, poi, in cerca di un lavoro più stanziale, hanno preso in gestione un distributore di benzina . Giampiero riempiva le vetrine del gabbiotto di citazioni letterarie. Un cliente architetto, Pasquale Pinna, gli ha proposto di fare il libraio . E così è nato Il viaggiatore immaginario, una libreria che ad Arezzo è un’istituzione. La differenza la fa la competenza : Gianpiero consiglia e perfino sconsiglia, Marina ripara con la naturale gentilezza agli spigoli del marito: le vetrine sono un esempio di come si possa essere creativi , proponendo estrosi temi, tipo “ la mezzanotte”o “ provviste per l’inverno”: chi è incuriosito può vederle nel loro sito. Una catena voleva rilevare tutto, comprare il magazzino e assumere i due librai. Ma non si vende un sogno, per di più ben realizzato.
Luigi Licci era un broker di successo, che per il suo lavoro viaggiava in tutto il mondo. Alla passione dei viaggi si accompagnava quelli per i libri di viaggio : quando si è stufato del suo mestiere Luigi ha preso la libreria Gulliver, nel centro di Verona, e ne ha fatto un punto di incontro. Una volta mi ha invitato a presentare un libro in una villa nella campagna , in una serata infra settimanale : non ci sarà nessuno, pensai. Arrivarono cento persone : ci fidiamo delle proposte di Licci, mi dissero. Io pensai alle tante presentazione male organizzate e peggio pubblicizzate di grandi librerie di catena a Milano o a Roma .
Di Danilo mi hanno raccontato due lettori viaggiatori incontrati in India, Ruggero e Paola . La libreria Quo Vadis di Pordenone è un punto di incontro di veri viaggiatori che il libraio aiuta anche nella preparazione del viaggio. Come se , comprando un libro di cucina, , il libraio ti accompagnasse anche a fare la spesa. Danilo lavorava in un’industria tessile, la crisi è stata la spinta a mollare gli ormeggi e partire. Ha sempre letto letteratura di viaggio , è la sua passione. “ Ho viaggiato molto tra le righe”, dice. Appena mi capiterà di passare dalle sue parti non mancherò di visitare la sua libreria. Tutte le librerie sono luoghi di confine , ma la Quo Vadis di Pordenone di più.
Come sostenere queste vere librerie ? Semplice, non ci facciamo allettare da un euro in più di sconto : un buon libraio tiene titoli che non troveremo mai nei supermercati, conosce i tuoi gusti, si impegna nella ricerca di un libro “scomparso”, ospita senza pressare all’acquisto persone affini, che magari diventano amiche.
Non è avido, altrimenti venderebbe merci dove si ricarica il trecento per cento e non quel magro trenta da cui levare spese , stipendi … e sconto .
Ho raccontato solo tre storie , trasmigrazioni da lavori diversi, per questa avventura coraggiosa che è aprire una piccola libreria in provincia. Non si offenda chi non ho citato. Spero che chi legge racconti altre librerie, altre storie. Pubblicità manifesta , per evitare che piccole luci di cultura si spengano.